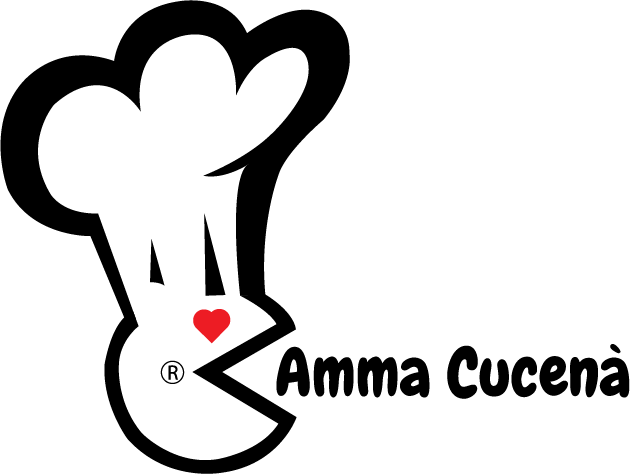“Trago dentro do meu coração, Todos lugares onde estive: A entrada de Singapura O coral das Maldivas Macao da noite, a uma hora.” Franco Battiato (Segunda-feira)
Mi fa strano tornare con la mente e riportare il cuore senza stropicciarlo a tre anni fa, a quando si poteva prendere un aereo senza test e senza pass e cambiare paese, continente, lasciarsi inseguire dal sole o inseguirlo, proteggendosi dalla sua luminosità con un’abbassata decisa di tendina dell’oblò… Su un aereo, all’epoca, l’unica cosa da proteggere era solo lo sguardo assonnato da un abbaglio di luce ostinato e troppo forte.
Dell’Asia, le prime atmosfere gustative che mi arrivavano, soprattutto nell’adolescenza, erano le spezie e le salsine portate a Procida da Diana la canadese. Lei si riforniva nella Chinatown di Toronto, che poi da grande avrei potuto visitare e annusare direttamente anch’io.
Noi le custodivamo in un bauletto di vimini, nell’entrata di casa a Via Curato. Potevamo usarle, cucinare, avventunarci verso sapori mai provati ogni volta che ci andava.
Poi c’erano stati i ristoranti cinesi durante gli anni di studio fuori sede nella sede non troppo lontana di Napoli. Si iniziava a prendere confidenza col maiale in agrodolce, gli involtini primavera, il gelato fritto, il litchi, il bambù, i funghi neri. Qualche anno dopo, c’era stata Lisbona, con l’invito fisso del jantar de anos* nel ristorante cinese di turno, preferibilmente in una zona più commerciale che centrale: ai portoghesi di quegli anni piaceva così… Insomma, l’Asia mangereccia in quel periodo era tutta lì.
Quando lasciai il Portogallo per la Francia, nel mio immaginario d’oriente iniziarono a spuntare i ristoranti giapponesi della Rue Saint Anne di Parigi – e noi tutti concentrati a scovare il miglior susharo della zona – per poi finire ai Thai londinesi o di Lille e a un cinese autentico di Oxford, dove la voce troppo borghese di chi andavo a trovare mi parlava anche dei dim sum di un mercato infrasettimanale a cui i confini temporali dei fine settimana mi impedivano di accedere: diceva che no, proprio non potevo capire senza assaggiarli. Capire cosa, non l’ho mai capito: chiamavo banalmente ravioli cinesi quella infima parte di dim sum che pur non avendoli mangiati nei mercoledì di Oxford conoscevo già… Per molto tempo ho creduto di arrivare in ritardo sui termini sfoggiati dalla borghesia, pure quando ero in anticipo o in contemporanea. Eh sì, erano gli anni di piccole, grandi ingenuità e di poca voglia di rivendicare.
Prima dei thai di Lille e della Cina da venerdì a domenica di Oxford, c’era stata una Tailandia in loco.

Si trattava di una Tailandia vera, una Tailandia seria, assaporata in un afosissimo mese di luglio, una Tailandia di templi e Buddha giganti e dorati, di spiritualità osservate, di piccantissimi pad thai a praticamente un euro all’ultimo piano di un centro commerciale di Bangkok, di insalatine di vermicelli di riso e citronella altrettanto piccanti su un’isola senza ombra di continente intorno. A Bangkok, ad Ayutthaya, gli odori del cibo di strada si mischiavano ferocemente a quelli del traffico e mi rendevano scettica verso ogni tipo di bancarella mangereccia.

E poi, tre anni fa, il viaggio a Hong Kong, a Macao, a Singapore (di cui parlerò in un altro post) tappe in realtà per andare e tornare, la meta vera era l’Australia, a trovare amici conosciuti in Francia: una cara amica e il suo compagno.
Di quel viaggio, il primo ricordo andando a ritroso in ordine cronologico è il risveglio il giorno della partenza, di ferragosto, a Lille con un’otite lancinante. Mi aspettavano 2 aerei nel primissimo pomeriggio, uno da Parigi a Monaco di Baviera e l’altro da Monaco a Hong-Kong. Prendere l’aereo con un’otite non è proprio l’ideale, quindi, poche ore prima di salire sul treno che mi avrebbe portata in aeroporto, mi precipitai con tutta la valigia da SOS médecins, aperto anche di Ferragosto, spiegando la drammaticità della situazione. Il medico di guardia, dopo un’attenta visita, mi prescrisse cortisone per 2 giorni e, in caso di mancati miglioramenti, antibiotico.
E cortisone fu, tipo alle 11h di quel mattino, che poi sarebbero state le 17h del giorno dopo a Hong Kong col fuso orario – contando le 24 ore per riprendere una dose – e il cortisone, mannaggia ai gingilli, non fa dormire. Ricordo una lunga telefonata con i miei dall’aeroporto di Roissy a Parigi prima di fare il check-in e salire sul primo aereo: entrambi si mostrarono abili nel mascherare preoccupazioni e mi davano fiducia, incoraggiandomi a non rinunciare a quel viaggio che avevo preparato da tanto e incitandomi a confidare nell’effetto del cortisone.
Hong-Kong, tra zampe di gallina, i veri dim sum e i 10 000 buddha
E fu così che mi ritrovai insonne la prima sera e notte di medicamenti sull’aereo Monaco-Hong Kong, a pregustare di nuovo l’Asia vera assaggiando un pollo in agrodolce cantonese e a chiacchierare con le mie due vicine di posto: una mamma e una figlia adolescente. Erano inglesi, stavano viaggiando già dalla mattina, dall’Inghilterra, per recarsi in visita a qualcuno di famiglia a Hong-Kong. Una notte a inseguire il sole nonostante il buio dell’aereo, a guardare film e a leggere la guida sulla prossima tappa. Una notte e un atterraggio senza smettere di ingoiare, sbadigliare, masticare per aiutare l’orecchio. Una notte e poi tante isolette sul Mar Cinese e l’arrivo a Hong Kong, al “porto profumato” e, nello specifico, all’aeroporto di Check Lap Kok.
A Hong-Kong ci si sente (o almeno ci si sentiva all’epoca) a proprio agio già da appena ci si arriva. Tutto è organizzatissimo e indicatissimo, con la metropolitana si accede direttamente al cuore della città e alle sue zone nevralgiche.

Per le due notti passate nella metropoli cantonese alloggiai al quindicesimo – o forse oltre – piano di un albergo situato nei pressi della fermata di North Point. L’uscita della metro si rivelò provvidenziale per i chioschetti degli snack di emergenza: il mio preferito, una specie di cookie al matcha e cioccolato bianco.
Arrivai all’alloggio nel primo pomeriggio, con la colazione salata dell’aereo ad anticipare sempre di più i profumi d’Asia bella che digerita. Un primo giro ritmato da un diluvio inesorabile nel quartiere mi fece osservare con curiosità le vetrine dei ristoranti popolari, frequentati perlopiù da uomini. Dietro ai vetri schizzati dalla pioggia, in bella mostra, trionfavano mega zampe di gallina, pollo o pterodattilo (viste le dimensioni) e anatre da laccare. Nessuno di quei posti di soli uomini e con i resti di pennuti a pelle nuda in evidenza mi attirò.

Mentre preparavo questa tappa a Hong-Kong, cercavo informazioni sulla cucina tipica di là. I Dim Sum la facevano da padroni su tutti i blog, siti e guide consultati. Un’altra cosa tipica in cui mi imbattevo nelle varie letture era la zuppa di pinna di squalo. Si tratta di un piatto popolare in Cina dai tempi della dinastia Ming. Io però non provai nemmeno a cercare questa zuppa sul posto, soprattutto dopo aver appreso come viene effettuato il reperimento di pinne di squalo: si mette in atto lo Shark finning, ovvero lo spinnamento, una pratica che consiste nel tagliare le pinne agli squali mentre sono ancora in vita per poi rigettare in mare il resto del corpo. Gli squali, privi di pinne, passano giorni di agonia prima della morte. Si tratta di una pratica dalla crudeltà estrema, attraverso la quale ogni anno vengono uccisi 90-110 milioni di squali nel mondo, mettendo in serio pericolo l’esistenza di questo pesce. Ragion per cui, la zuppa di pinne di squalo andrebbe decisamente boicottata**.

Assodato che non avrei mangiato né big pennuti né pinne di squalo, mi avviai alla scoperta dei punti salienti della città, accompagnata sempre da una pioggia torrenziale e intermittente e dalla luce del giorno che si andava via via attenuando.
A Hong Kong, più dell’imperativo catagorico “Amma Cucenà” vigeva, almeno all’epoca, l’imperativo categorico dell’”Amma Magnà”…. In quei due giorni e mezzo passati lì, osservai gli abitanti del posto trangugiare qualsiasi cosa e a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Dopo qualche fermata e un cambio di linea di metropolitana mi ritrovai a passeggiare tra i neon e i colori del Ladies Market, una specie di Bùvero di Sant’Antonio o la Duchesca locale in versione notturna, per capirci. In questo mercatino si trova veramente di tutto: vestiti, pigiami, zaini e borsette, pupazzetti, gattini con la zampa sventolante che fanno tanto cinese e chi più ne ha più ne metta.

Girai incuriosita per tutte le bancarelle senza comprare nulla, poi, arrivata l’ora di cena, mi infilai in un ristorantino lungiforme e discretamente affollato, sempre rispettando la massima di mio padre “quanno nu ristorante sta iss’e i tavulini nun se mangia buon!”***. Sfogliai il menù, scritto in cantonese e in inglese e corredato di foto e la mia scelta cadde su un’ottima zuppa phô, accompagnata da piccoli chángfěn 肠粉 e da una dissetante acqua di cocco, direttamente dalla noce, bibita che poi, insieme al tè verde, diventò immancabile durante tutto il mio breve soggiorno asiatico.
La zuppa phô è un piatto innanzitutto vietnamita, poi adottato anche dai laosiani, fino a diventare una delle piatanze nazionali in Laos e si trova in molti ristoranti asiatici, anche in Europa. Si tratta di un brodo generalmente di manzo, servito con noodle di riso, pezzi di manzo, pollo (meno frequente) o polpette di manzo, basilico thai e lime. Insieme alla zuppa, viene portata anche una ciotolina con germogli di soia da aggiungere a piacimento. La variante che presi io e quella che prendo sempre quando la trovo è la Phở bò viên, con le polpettine di manzo.

I chángfěn (肠粉), invece, sono dei fogli bianchi di amido di riso, arrotolati a mo’ di involtini/fagottini farciti con vari ripieni: se ne possono trovare col maiale, il manzo, i gamberetti, pesce, ostriche, uova, funghi, uova di pesce, crescione. I miei di quella sera erano ai funghi neri. Questi fagottini, che non avevo mai assaggiato, sono un classico della cucina cantonese e sono reperibili in tutti i posti di dim sum, nei ristoranti del tè mattutino o negli street food e bazar notturni. Più in basso, ne troverete un’altra variante, più grande, perché mi ritrovai a ordinarli almeno due volte: li apprezzai moltissimo!
Dopo essermi rifocillata in quel ristorantino pieno e lungiforme, gestito da due signore frettolose ma gentili, ripresi a girovagare incuriosita tra i vicoletti e le arterie principali del Ladies market, osservando anche i bancarielli degli street food.

A un certo punto, stanca del viaggio e di tanto camminare, decisi di battere ritirata, mentre la seconda dose di cortisone faceva già sentire i suoi effetti sgrana-palpebre. Giunta nell’albergo, dopo qualche pagina di lettura della guida di Hong-Kong per studiare le tappe del giorno seguente, provai ad addormentarmi. Girati di qua, girati di là, rumore di ventilatore, mitt u lenzul, lèv u lenzul, gir u cuscino, vòta u cuscino, proprio quando stavo per prendere sonno dopo sforzi titanici, zac, la voce ululante di… rullo di tamburi… nu francese. Addio sonno, si risgranarono le palpebre! Fresco di diploma in una Grande école de commerce e di trasferimento nella megalopoli asiatica, il giovane transalpino raccontava sbraitando alla famiglia via Skype la sua prima giornata lavorativa negli uffici dei grattacieli di Hong-Kong. Sentivo tutto, distinguevo ogni minima parola. Provai a resistere, ma a un certo punto mi vidi obbligata a uscire sul pianerottolo e a bussare timidamente alla sua porta. Incredulo, il giovane businessman francese commentò quella bussata coi suoi interlocutori a distanza “on frappe à ma porte??? Quelqu’un frappe à ma porte” (bussano alla porta? Qualcuno sta bussando alla porta?) e poi venne ad aprirmi. Pure ‘nterr Hong Kong, mi ritrovai a ripetere la scena coi vicini fastidiosi con la musica a palla a Lille: per favore abbassa il volume – questa volta solo della voce, per fortuna. E per fortuna il ragazzetto si rivelò a modo, fu comprensivo e riuscii a fare una bella nottata di sonno nonostante il cortisone, il rumore di ventilatore e l’adattamento al fuso orario.
Il giorno dopo mi svegliai pimpante di buonora e con l’orecchio completamente guarito. Decisi di fare un giro del quartiere dove alloggiavo, anche per cercare un posto per la colazione. Mi feci mandare via in cantonese da una specie di ricevimento che non si capiva che era un ricevimento… Ci ero capitata per sbaglio, all’ultimo piano di un centro commerciale. Fuori continuava a esserci una pioggia torrenziale e rimasi stupita -in senso negativo- da quanta plastica si usasse all’entrata di negozi e centri commerciali per proteggere i propri ombrelli. Dopo essere stata cacciata in cantonese dal ricevimento, mi ritrovai in una specie di Starbuck molto locale, al piano terra di quello stesso centro commerciale. Decisi di fare colazione lì, con tè verde e una tartelette al matcha che però non mi entusiasmò… troppo dolce.

Dopo la colazione ripresi a girare per il quartiere, entrando e uscendo anche da supermercati per vedere cosa si magnano/comprano gli abitanti di Hong Kong. Concluso questo giro mattutino, poco prima di ora di pranzo, mi avviai in metro verso il luogo di interesse che avevo deciso di visitare, il Ten Thousand Buddhas Monastery (il Monastero dei Diecimila Buddha). Per arrivare, dovetti cambiare di nuovo linea di metropolitana e apprezzai una parte in cui il treno circolava all’aperto, attraversando quartieri residenziali immersi nel verde. Giunta allo spiazzale da dove poi partiva il vicoletto di accesso al tempio, osservai le persone del posto, il capolinea di autobus di linea e pulmini colorati. Si era fatta ora di pranzo, così decisi di fermarmi in un posto spartano, a cui si accedeva da uno “spiazzale nello spiazzale”. Era pieno, soprattutto di lavoratori e lavoratrici in pausa pranzo, quindi ci si ritrovava a dividere il tavolo con sconosciuti. Ero l’unica non asiatica, ma non mi sentii a disagio. Memore anche dei consigli di mia madre sull’alimentazione per cortisone, nella telefonata del giorno prima – “m’arraccumanno, nun t’azzazzerià!” – optai per un leggerissimo Pac-Choï con funghi e gamberetti accompagnato da una ciotolina di riso in bianco e un immancabile tè.

Dopo quella pausa localissima e rifocillante, iniziai a intraprendere la salita delle scalette della collina dove si trovava il tempio, che in realtà erano 4. Il cielo alternava nuvole e sprazzi di sole e c’erano veramente tanti buddha dorati ed espressivi ai lati delle scale, non contai se erano veramente diecimila. La salita fu lenta per osservare quelle creature immobili e farsi osservare da tutti quegli occhi. Ogni tanto si incrociavano turisti o devoti in discesa. La salita, ci si rende conto una volta su, è la cosa più bella di questo posto, perché i templi sembrano essere più funzionali che carini

Tornata a valle, presi di nuovo la metropolitana e mi spostai verso tutt’altra zona: la promenade di Tsim Sha Tsui, un bellissimo lungomare sul porto di Hong Kong, con vista su navi turistiche o cargo, battelli per minicrociere e ricostruzioni di antiche caravelle. Inutile dire che questo posto era molto più affollato del complesso di templi dei 10 000 Buddah, si vedevano persone di ogni dove e di tutte le età, quasi tutte attrezzatissime con mazza da selfie per catturare la posa e il momento migliore di quell’ultimo pezzo di pomeriggio.

La serata di quel venerdì, l’avrei dedicata a provare un posto di dim sum recensito su un blog che avevo letto prima della partenza (Travel and Marvel) e che faticai non poco a trovare. Il fatto è che non potevo usare google maps senza connessione e la connessione in 4g ti faceva sforare tutte le soluzioni di forfait possibili e immaginabili. Avevo optato per degli screenshot del percorso, presi dall’albergo in modalità wifi. Nonostante gli screenshot, però, non mi ritrovavo e allora chiedevo ai passanti che, a loro volta, consultavano il proprio google maps con comandi vocali, in un salire e scendere di intonazioni – dovevo sforzarmi per restare seria…
Chiedi a uno, chiedi a un altro, giunsi finalmente a destinazione al Dim Dim Sum, locale giustamente affollato, vista la bontà dei piatti serviti e con personale che si rivelò un po’ truce, almeno con me. Anche in questa situazione ero l’unica non asiatica. Per ordinare bisogna riempire delle caselline a fianco ai piatti scelti, e visto che mi misero fretta, andai sul sicuro con una porzione del mio colpo di fulmine culinario locale: i chángfěn, accompagnati questa volta da bao fritto.
Completai l’ordine con una carne di maiale gelatinosa, tutta nervi e a tocchetti, ma piuttosto saporita. Vedevo passare cose molto invitanti sui tavoli dei vicini ma, ahimè, non riuscivo a identificarle sul menù, mi ritrovai abbastanza lost in translation nonostante gli ingredienti scritti in inglese.
La mia prima parentesi nella megalopoli cantonese si chiuse il giorno dopo, con una visita al Victoria Peak, un altro pranzo al volo sempre in un posto che serviva dim sum e un imbarco al porto, direzione Macao.
Macao, le sue tracce portoghesi e i troppi casinò
Per andare a Macao, o si prende l’aereo, oppure, soluzione più comoda per chi si trova già ‘nterra Hong Kong, se pigghi’u catamarano.

Ragion per cui, con all’attivo cinque anni a fare la spola marittima tra Procida e Ischia per andare al Liceo e dopo una vita a prendere traghetti, aliscafi, catamarani, natanti e buattelle varie da Procida per Napoli o Pozzuoli (e ritorno) mi ritrovai a imbarcarmi su un catamarano rosso fiammante dal porto di Hong Kong per raggiungere quello di Macao.
Grande emozione nel trasporre un’azione abituale da un posto familiare a uno esotico e remoto, grande curiosità nel confrontare il natante asiatico con quelli dell’area flegrea. Risultato del confronto: l’imbarcazione della tratta Hong-Kong-Macao era più aggraziatella, con i sedili un po’ di stoffa e un po’ in simil pelle sulla parte dei poggiatesta e le zone metalliche interne passate a lustro.

Prima di quel viaggio, Macao, erano davvero anni che ero curiosa di visitarla… Dal primo anno di portoghese, all’università, mi avevano sempre detto che a Macao si parlava proprio quella lingua e, soprattutto, volevo usare l’evocativa “Pataca de Macao”, quella che, insieme alla Pizza de fango del Camerun, stracciava la Lira al cambio secondo quanto diceva la Signorina Vaccaroni, quella di Avanzi, quella che lavorava “dalle otto alle otto”.
Che presumibilmente lì si parlasse portoghese un po’ mi faceva storcere il naso e un po’ mi faceva illudere sul fatto che avrei comunicato facilmente con le persone del posto… E invece… Già da Hong Kong, quando avevo Wifi, comunicavo in inglese (e non in portoghese) con le persone della casa dove avevo preso una stanza per quelle due notti trascorse Macao. Mandarono a prendermi un giovanissimo coinquilino, per indicarmi la strada e aiutarmi a portare la valigia. Il punto di incontro era l’entrata di un lussuosissimo hotel-casinò. Quello che sarebbe stato anche mio coinquilino per i prossimi 2 giorni si avvicinò senza che io lo riconoscessi e si chinò verso la mia valigia. Il gesto scatenò in me un’immediata reazione da pensionata anni ottanta all’uscita della posta in difesa della sua burzetta adocchiata dai malfattori – si tenevo na burzetta cchiù pesante, ce l’avessa tirata ‘ncapa: gli ci volle almeno un minuto di grandi gesti e spiegazioni né in inglese né in portoghese, ma in cantonese stretto e di cui non capivo neanche una parola, per tranquillizzarmi e farmi fidare di lui. Il coinquilino mi accompagnò alla casa macaense, trascinando la valigia che ormai avevo accettato di farmi trascinare e sorridendo e facendo sì con la testa quando sembravo capire quello che mi stava raccontando, sempre in cantonese stretto.

Giunti a casa, capii che bisognava togliersi le scarpe all’ingresso e che potevo usare le ciabatte di plastica per gli ospiti. Quel coinquilino fu l’unico che incrociai nelle soste della casa di Macao. La finestra della mia stanza affacciava sul pianerottolo, lato ascensore che faceva blin-blan a ogni salita e discesa… Si annunciavano due notti di sonno difficile da trovare…
Anche lì a Macao, quella prima sera, optai per i dim sum, provandone 2 tipi, uno molto gelatinoso, con uova di pesce e uno un po’ più classico, sempre con cose di mare.

Questo posto di dim sum, poco affollato rispetto agli standard di locali di Hong Kong, si trovava nella strada dell’appartamento dove alloggiavo, la portoghesissima (per fortuna solo di nome) Avenida de Roma. Una volta rifocillata, nonostante la tarda ora, il buio della zona e il caldo afoso, decisi di avventurarmi in direzione dei quartieri-casinò. Non ho mai visto Las Vegas e me la immagino proprio come Macao di notte. Il buio del centinaio di metri prima era stato inondato di insegne colorate, murature dorate illuminate a giorno e fontane sberluccicanti. I nomi dei casinò erano in caratteri occidentali. Il mio sguardo preferiva posarsi su luci rosse e ideogrammi, che non annunciavano casinò e non mi facevano capire nulla sull’edificio che avevo davanti. Avevo bisogno di trovare uno spaesamento più rassicurante, l’occidentalità ostentata dai casinò mi metteva a disagio. Che posto strano…

Il giorno dopo, ero decisa a tenermi lontana dai casinò per dirigermi verso il centro storico e osservare le vestigia portoghesi della chiesa da Madre de Deus (Ruínas de São Paulo), perdermi tra i vicoletti e poi, a un certo punto, spostarmi in autobus verso Taipa, per visitare la “Casa-Museu” e cenare nella tasca alentejana del signor Santos, posto consigliatissimo da una coppia di amici franco-finlandese che aveva vissuto anni prima a Hong-Kong. Dare inizio a questo programma non fu la più semplice delle cose, visto che, ancora una volta, con gli screenshot di google maps registrati sul telefono nell’appartamento, non mi raccapezzavo e mi ritrovai ad allungare di molto il percorso. La cosa, alla fine, si rivelò piacevole, perché mi fece imbattere, ad esempio, nel Tempio di A Ma, luogo sacro dedicato non ai romani de Roma che chiamano la mamma ma… ai naviganti. Devo dire, il mio monumento e luogo sacro preferiti a Macao, ma anche a Hong Kong, forse perché i naviganti a cui era dedicato non mi facevano pensare ai portoghesi, ma ai naviganti tout court. O forse ai procidani me compresa.

Ma cosa c’entrano i portoghesi con Macao? Macao ha la particolarità di essere stato il primo, ma anche l’ultimo insediamento europeo in Asia. I portoghesi vi sono arrivati nel 1554 o 57, stabilendovi il primo avamposto commerciale europeo della Cina (seguito poi da quello religioso e quello culturale) operazione che portò alla fondazione della Cidade do Santo Nome de Deus de Macau, “in onore del fiero e fedele difensore della presenza e della cultura portoghese in Estremo Oriente”. Da allora Macao divenne colonia portoghese.
Il 19 dicembre del 1999, il governatore Vasco Rocha Vieira assisté all’ultimo ammainabandiara, aspettando che, a mezzanotte, il Portogallo restituisse Macao alla Cina, archiviando così la presenza europea in Asia. In realtà, nel 1974***, quando Lisbona riconobbe l’indipendenza delle colonie africane, anche per Macao doveva finire la presenza portoghese, anzi, si pensava che con la rivoluzione dei Garofani, la colonia in Asia sarebbe stata la prima perdita. Però, contrariamente a quanto accadde con le colonie in Africa, Macao fu più volte offerta alla Cina dai portoghesi, ma Pechino informò Lisbona sulla sua volontà di mantenere lo status quo, sottolineando che la questione non era urgente. I cinesi optarono per una transizione più morbida per Macao, concentrando le loro energie soprattutto su Hong Kong. Quest’ultima passò dal dominio britannico alla sovranità della Repubblica Popolare Cinese nel 1997, pur mantenendo uno statuto di regione amministrativa speciale (stesso statuto vigente a Macao).
Insomma, vedere il tempio di A Ma, in quei luoghi, aveva più senso degli inciampi sulle pareti tappezzate di azulejos.

L’unica cosa che faceva digerire le tracce di passato coloniale era il senso di tranquillità dato da antichi riferimenti architettonici europei ritrovato dopo un’abbuffata visiva di grattacieli adibiti soprattutto a casinò. Ma anche quel senso di tranquillità era un artificio…
Tracce portoghesi più digeribili le trovai in una pasticceria fusion e nella conversazione, questa volta in portoghese, minha língua de descanso, con un pasticcere, di mamma portoghese e papà di Macao. L’uomo, tra le cose più interessanti, mi raccontò che a Macao si potevano trovare, sì, i pastéis de Nata in una versione molto simile a quella portoghese, ma lì avevano creato anche una loro versione dell’emblematico dolcino di Belém: il “dàn tà” (蛋 挞) (detto anche “portuguese egg tart”). Questa variante di Macao è meno dolce e meno caramellata rispetto all’antenata portoghese e per prepararla, invece della pasta sfoglia, usata per i pastéis de nata, si opta per la pasta brisé (un vero sacrilegio, direbbero i pasticceri di Belém). Altra differenza importante è che nella variante di Macao ha iniziato a fare capolino l’uso del latte condensato per rendere la crema del dolce ancora più liscia e lucida. Ci sono anche delle versioni di dàn tà con crema al matcha. Nun ce sta niente ‘a fà: la cucina è sempre l’elemento più conciliatore…

Ma passiamo a Taipa e al signor Santos, che andai a trovare la sera di quello stesso giorno. Raggiunsi l’isola di Taipa, collegata alla penisola di Macao da un lungo ponte, dopo aver preso un autobus alla fine di diversi tentativi di ricerca della fermata giusta per salire e dopo un’attenta osservazione di tutte le fermate oltre il ponte alla ricerca della fermata più conveniente per scendere. Visitai la Casa-Museo, altra traccia coloniale un po’ più esplicita e anche ben tenuta e cedetti alla curiosità di attraversare i corridoi tra i tavoli di gioco del casinò del Venetian Hotel: mi colpì la quantità e soprattutto la varietà di persone in termini di genere ed età, si aveva l’impressione che per loro giocare alla roulette era come farsi un paio di giocate a tombola a Natale.
Affollato era anche il ristorante Santos Comida Portuguesa, dove mi fecero accomodare al primo piano, annunciandomi subito di non avere disponibile il loro piatto forte, l’arroz de mariscos. Mi vidi obbligata a ripiegare su un bacalhau assado con patate e un arroz doce come dessert, consigliata dal Signor Santos in persona. Parlai a lungo con lui, del fatto che avevo abitato in Alentejo, a Serpa, per un anno, di come ci ero finita, di come mi erano piaciute la gente e le pietanze del posto… ci soffermammo su formaggi di pecora, carne di maialino nero, açorda fatta col pane raffermo, col coriandolo e i frutti di mare. Quell’Alentejo comune, terra natale del Signor Santos, porto sicuro, pur senza mare, di un anno bello per me, bastò a non farmi volere andare oltre sulle ragioni del suo arrivo a Macao. C’erano foto di lui da marinaio, di navi militari in bianco e nero. Ma io volli concentrarmi soprattutto sul rosso della maglia del Benfica e sulla sciarpa da reggere insieme per la foto di rito, scattata con le amiche e gli amici della tasca alentejana più accogliente di Taipa. La bellezza, anche quella accecante portoghese, ha avuto zone d’ombra da illuminare con il tempo.

Il giorno dopo, di mattina molto presto, avevo il catamarano di ritorno per Hong Kong, dove avrei passato solo la giornata. Quella mattina stessa, ebbi la possibilità di registrare la mia valigia in una stazione della metro di Hong Kong centro, per spedirla e ritrovarla direttamente nella prima città australiana che avrei visitato. Senza pesi e senza pensieri, per la mia ultima giornata a Hong Kong, mi aspettava il buddha gigante dell’isola di Lantau, da raggiungere con una cabinovia dalla vista mozzafiato.

Dopo tanta meraviglia e il caldo appiccicoso, la sera mi aspettava un’altra notte in aereo per raggiungere Melbourne e il suo freddo inverno. Una notte di viaggio, come quella dell’aereo Monaco-Hong-Kong, come tutte quelle passate in treno per andare a trovare il mio papà. Come quella dell’autobus da Madrid a Logroño, dove ad aspettarmi, alle 5 del mattino, c’era il papà di una mia amica – attento e commovente – o come quella del treno Lunea da Parigi a Barcellona per raggiungere le care procidane nella trasferta di un addio al nubilato. Come quelle sul finire – soprattutto sul finire liberatorio – delle Oxford-Londra Paddington-Londra Saint Pancras – Lille Europe. E come quelle che da quando c’è il covid, non possono essere perché treni e autobus di notte non li fanno più girare.
E io intanto penso a una notte che vorrei passare in aereo per tornare dal Brasile… O, restando in tema di Asia, per raggiungere il Giappone e le file chilometriche per assaggiare il ramen più buono di tutti.
Jantar de anos*: Cena di compleanno
**Fonte: Jaws: 73 milioni di squali uccisi ogni anno per la zuppa di pinne (cittadellascienza.it) )
*** Il 1974, è l’anno della Rivoluzione dei Garofani, della fine della dittatura in Portogallo e dell’indipendenza di alcune colonie portoghesi, soprattutto in Africa.