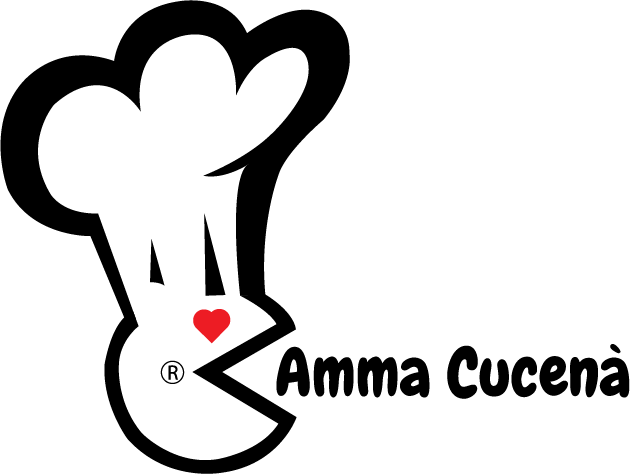L’estate scorsa, ad agosto, in occasione della serata di chiusura della Fiera del Libro di Procida, ebbi la fortuna e l’onore di essere accompagnata nella presentazione di Chicken Parmigiana da Maria Iovine e Clelia Ambrosino in un bellissimo dialogo. Durante la preparazione dell’evento, parlando della Chiaiolella con Maria e pensando alla storia dei discendenti di Crescenzo, le avevo chiesto se, con calma, avrei potuto intervistarla per la rubrica Cuoc@ nostrom@ di questo blog. La sera della presentazione, poi, mentre mi avviavo verso le signore dell’associazione Borgo Marinaro che stavano preparando panini con la parmigiana, incontrai senza riconoscerla a prima vista Anna Scotto, che si fermò a parlare con me della presentazione appena conclusa. A un certo punto, mi chiese “a chi appartieni?” e io iniziai a nominarle i miei genitori di Solchiaro, mia nonna paterna che teneva u malazzé a Chiauledda e piano piano, continuando a parlare, riconobbi Anna, accorgendomi di conoscere sua figlia e una sua sorella. Fu una breve e piacevole chiacchierata. Lo scorso gennaio io e Maria ci siamo messe d’accordo per realizzare l’intervista a cui ha partecipato anche Anna, alla fine di un freddo pomeriggio post-Epifania, nell’unico bar aperto tra Olmo e Chiaiolella nel periodo. Da quell’incontro è venuta fuori una chiacchierata eclettica, nostalgica, intima, sociologica e anche un po’ rivoluzionaria. Sono infinitamente grata a Maria e ad Anna per aver aggiunto un altro bellissimo pezzo al puzzle di voci procidane di Cuoc@ Nostrom@.
Cucenellista: Una domanda per Maria, per ricostruire la storia di Crescenzo, pretesto iniziale di questa intervista: come si è creato il legame tra la tua famiglia e la ristorazione, fino a farvi diventare punti di riferimento per la gastronomia procidana?
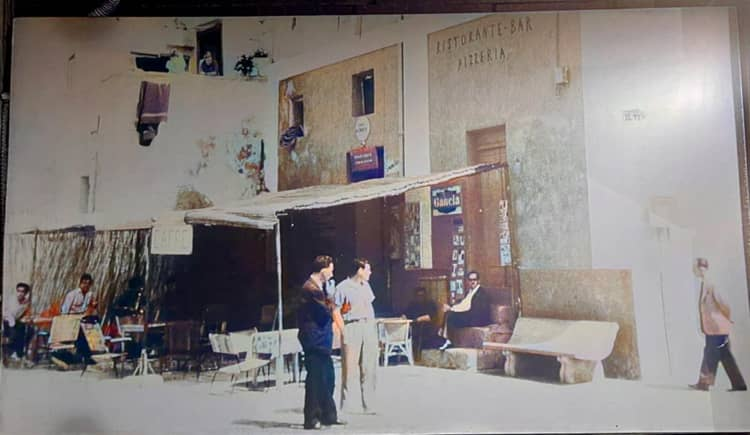
Maria Iovine: Allora, dobbiamo rifarci al 1956, quando fu costruito il Ponte di Vivara. Mia madre e mio padre erano già sposati dal 1947. Lui era di Ischia, anzi di Barano d’Ischia, e veniva a Procida con la nonna paterna a vendere i prodotti dell’orto. Conobbe mamma, si innamorò e si sposarono. All’inizio lavorava un po’ col nonno, che aveva una piccola salumeria dove vendeva stoccafisso, farina, pasta, queste cose qua.
Poi, quando ci fu la costruzione del ponte di Vivara, mio padre capì subito che sarebbe stata una cosa importante per lui. Cominciarono ad arrivare tutte le maestranze, nonché il gruppo dirigente. Queste persone avevano bisogno di qualcuno che cucinasse per loro, allora mio padre mise subito mia madre ai fornelli.
Cucinavano per tutti gli operai che partivano la mattina presto con le barche per andare a costruire questo ponte e tornavano la sera morti di fame e mamma faceva trovare legumi, pasta, le cose che sapeva fare. Diciamo che lì lei tirò fuori veramente un talento eccezionale in cucina, perché in poco tempo la sua bravura arrivò pure ai dirigenti, che cominciarono a presentarsi a tavola. Così è nato questo rapporto tra la mia famiglia e la ristorazione: grazie al ponte di Vivara.
Per mio padre, venendo da Ischia, non è stato semplice inserirsi all’inizio a Procida, la realtà locale era molto chiusa. Lui era analfabeta, però era bravissimo a fare i conti e aveva una mentalità un po’ imprenditoriale. Devi sapere che il nostro primo ristorante è nato dove sta mo’ A Chiauledda, sempre per via del ponte di Vivara. Poi ci sfrattarono, arrivarono i carabinieri per cacciarci – non so di preciso cosa fosse successo – . Poi siamo passati dall’altro lato (dove si trova l’attuale Crescenzo) in quello che all’epoca era un palazzo diroccato, che era stato prima dogana, poi scuola elementare. A un certo punto, i padroni di questo locale lo misero in vendita e mio padre decise di comprarlo. Papà aveva una filosofia tutta sua: faceva le cambiali e poi alla fine dell’estate riusciva a pagarle. Mammà prucedana, questa cosa la temeva moltissimo. Lei mi diceva che papà imparò a mettere la firma per firmare le cambiali.
Quando comprò questo locale diroccato, re femmene ra Chiauledda gli dicevano “Crisciè, ma che t’e accattet, ‘ste quatt préte vecchie!” e lui pensava “te faccio avveré je c’addiventano ‘ste quatt préte vecchie”, perché lui, nella sua semplicità, con la sua visione del futuro, aveva già capito che quello era un posto magico, con un potenziale straordinario. Poi ha fatto l’albergo, il locale sul lungomare, aveva una capacità imprenditoriale non indifferente. Io ho lavorato nel ristorante fino al giorno prima di sposarmi. E c’era un po’ di razzismo – o invidia – perché non si ammetteva che noi Crescenzo riuscissimo a vivere senza ‘i pe’ mare… Comme fa Criscienzo a campà tutt chiri figghie senza i’ pe’ mare.

C: Quindi, nella tua famiglia, l’amore per la cucina ha creato delle figure professionali legate alla gastronomia o al suo racconto. Come si è trasmesso, poi, tutto questo alle tue figlie? C’è una continuità?
M: Innanzitutto con l’esempio: cucinare insieme, stare insieme. Poi è anche una questione di DNA: a un certo punto mia figlia Iris ha lasciato l’università per occuparsi di cucina e di vini, quindi l’ha sentito proprio dentro. Poi c’è l’ultima, Miriam, che è molto legata alla preparazione di ricette tradizionali: mi vede cucinare e mi imita. La seconda, Jessica, pure lei è molto legata alla cucina. Abbiamo avuto grandi esempi in famiglia connessi alla cucina. Mamma Vincenza aveva un talento innato: senza un ricettario, senza bilancia, senza niente, riusciva a portare in tavola piatti straordinari. Faceva un pollo al forno eccezionale, poi cozze bianche, cozze rosse, zuppa di pesce… Al ristorante venivano i migliori primari degli ospedali, che noi non conoscevamo. Purtroppo li abbiamo conosciuti quando mamma si è ammalata, quindi dai 45 ai 65-70 anni spesso veniva ricoverata e nei corridoi degli ospedali i primari andavano a salutare mio padre “uè Crescenzo, che ci fai qui?”. Una volta un signore le chiese una carbonara, che lei non aveva mai preparato. Si fece spiegare la ricetta, si procurò gli ingredienti e il piatto venne buonissimo. Dopo 15 giorni, quello stesso signore si ripresentò con venti persone per mangiare di nuovo la carbonara. Un’altra volta fece una frittata straordinaria… Insomma, era veramente bravissima. E poi aveva una mente matematica per calcolare le dosi per il numero di persone.
C: Com’è cambiato negli anni il rapporto tra i procidani e la cucina e, più in particolare, tra i procidani e la ristorazione?
M : Oggi i procidani escono, il sabato vanno a mangiare fuori, mentre invece in passato no, tutto era relegato all’ambito familiare. Adesso c’è una ricerca del locale dove si mangia bene, dove si viene accolti calorosamente, siamo più sensibili a queste cose. Prima, invece, almeno da come mi ricordo, c’era meno apertura, si usciva di meno, non c’era questa abitudine di andare a mangiare fuori.
I procidani però hanno sempre avuto piacere e passione per la cucina, soprattutto per quella di mare e anche per quella di terra chiaramente, perché c’è stato sempre un certo scambio tra le due cucine. Dalla Chiaiolella, dove c’erano entrambe le realtà (terra e mare) spesso i contadini si recavano alla Corricella (più prettamente di mare) per fare il famoso cala-cala, lo scambio tra i prodotti dell’orto e il pescato.
Questo rapporto tra le due realtà è sempre stato molto importante. Poi, in passato, ogni famiglia aveva un piccolo pollaio o una conigliera, i prodotti erano a chilometro non zero, ma super-zero. Quindi veniva fatto tutto nell’ambito familiare. Adesso invece le cose sono cambiate.
Anna Scotto: Prima, ad esempio, anche i matrimoni si facevano in casa: era la famiglia a occuparsi dell’organizzazione della festa e della cucina. Tutto si faceva tra le mura domestiche, nei cortili della propria abitazione, anche le comunioni, i battesimi.
M: Oggi, con tutta questa apertura, spero solo che la cucina da fast food tipo hamburger, McDonald’s non vada avanti, perché sarebbe veramente un peccato. Speriamo che i giovani avviino e continuino questa ricerca del gusto, dei prodotti genuini, di qualità, del vino buono.
C: Nel libro Storie e Sapori di Procida c’è una magnifica descrizione dell’affascinante figura del Rais: uno che conosce gli uomini, i pesci, il mare, le reti. Quanto mitologica è questa figura oggi? Possono la cucina, la pesca, l’agricoltura generare figure ancora così legate all’umanità e alla natura?
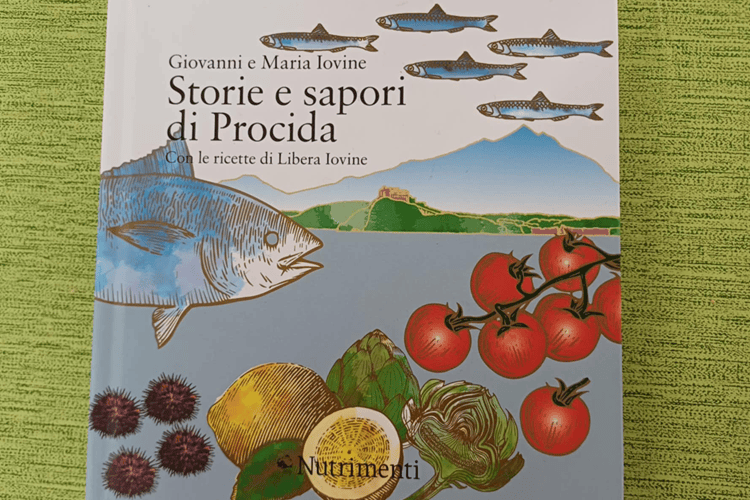
M: Allora, l’ultimo Rais della Chiaiolella era il padre di mio zio, Domenico, detto Dimino.
Prima, a Procida, c’era questa pesca della Tonnara. Come ho detto pure nel racconto, le reti venivano messe a Ciraccio, lungo la spiaggia e c’era l’abitudine appunto di lavorare insieme. Il Rais per me era una figura affascinante, perché conosceva veramente tutti e tutto: conosceva gli uomini, il suo equipaggio, sapeva chi era bravo a fare certe cose, chi invece doveva essere messo nelle retroguardie, visto che magari mancava di coraggio. Perché pescare il tonno era una cosa pericolosa. Quando arrivavano alla camera della morte, i tonni erano già impazziti dal dolore, perché erano stati pungolati con degli arpioni. Ci voleva molto coraggio.
Il Rais è una figura straordinaria e secondo me capiva anche il linguaggio dei tonni. Una volta, a Napoli, ho visto uno spettacolo e forse da allora mi è rimasta ancora più impressa questa figura. A un certo punto, l’attore parlava come se fosse un pesce, impressionante! Una cosa veramente straordinaria! Quindi il Rais conosceva in modo profondo tutto e tutti.
C: Mi è molto piaciuta questa cosa della camera della morte, perché la morte, e più in particolare la finitudine, è una cosa che oggi si tende sempre più a evitare nei discorsi…
M: A me invece sembra una metafora della vita.
C: Sì, sì, una metafora della vita, ma nel senso che la vita non si può conoscere e apprezzare appieno se non si conosce anche la parte della morte…
M: Infatti, perché tu entri tutto felice in questo percorso vitale, poi però ti aspetta la camera della morte. Tra l’altro il mio tonno alla fine riesce a liberarsi: il Rais lo libera perché è la sua ultima pesca.
Per quanto riguarda le figure mitologiche legate all’agricoltura, alla Chiaiolella, ne abbiamo avute tante: possiamo citare Nicola a Maest, Modest, il papà di Alessandro… Alessandro ormai è l’unico ad avere ancora una parula. Queste figure conoscevano la terra benissimo, sapevano tutto sul ciclo delle stagioni, sapevano quando piantare, conoscevano le fasi della luna (mancanza, criscenza): erano figure straordinarie, dai loro orti usciva veramente l’oro. Mi ricordo le parule di Nicola a Maest, con tutti quei pomodori: quello era un vero e proprio oro rosso. Quelle figure là, ma dove stanno più? La terra adesso è abbandonata. Peccato.
Poi un’altra figura importante, mitologica della mia famiglia, legata però alla cucina è stata nonna Pasqua. Una volta, per una comunione – come diceva Anna, queste feste si facevano in casa – lei preparò delle cozze ripiene che avevano un sapore! Io l’aiutavo anche ad ammazzare i conigli… Ne abbiamo ammazzati di conigli io e nonna Pasqua.
C: Per continuare insieme la riflessione, come è cambiato negli anni il rapporto dei procidani con la terra e con il mare? Procida ha ancora un rapporto privilegiato con questi due elementi?
M: Penso di sì, soprattutto con il mare c’è ancora un rapporto forte.
A: Sì, sono d’accordo, col mare di più.
M: Con la terra c’è stato un periodo in cui, a causa di costruzioni abusive, si è abbattuto di tutto e di più e questo è un peccato, perché gli antichi vigneti sono stati estirpati, alberi secolari sono stati tagliati, i limoneti sono stati eliminati. Dopo, però, è giunta una nuova consapevolezza e oggi vediamo molti papà che si dedicano all’orticello, a coltivare, a fare in casa le cose che servono in cucina, c’è il recupero di una nuova consapevolezza accantonata in passato.
A: Sono d’accordo e aggiungo alcuni ricordi legati alla terra di una volta. Quando ero bambina – avrò avuto dieci, dodici anni – il nostro papà non ci pensava due volte a dire a me e ai miei fratelli “venite che dobbiamo mettere le patate!”. A Natale si dovevano piantare, poi, quelle famose patate, andavano scavate verso Pasqua. Quindi noi eravamo obbligati a passare sempre le feste nell’orto.
Poi mio padre aveva le mucche e le persone venivano a prendere il latte a casa, oppure mio fratello andava con la secchia per tutta Procida, col freddo, gli stivaloni, a portare il latte ai bambini che aspettavano tanto. Da piccola ero sempre arrabbiata perché non volevo lavorare nell’orto, volevo andare a scuola. Però, adesso, se ripenso alle giornate che avevamo, le ricordo con grande nostalgia.
Noi abbiamo lavorato da quando eravamo bambine, le altre cose – u matrimonio, crescere una famiglia – sono venute di conseguenza. Però abbiamo affrontato tutto.
M: Sì, siamo anche molto cresciute da sole, nel senso che i genitori non si dedicavano molto a noi, dovevamo aiutare nell’orto, badare ai fratelli più piccoli.
A: Poi c’era poco tempo per giocare, io mi ricordo che quando tornavamo da aiutare papà nell’orto, ci cambiavamo, ci preparavamo per giocare e mia madre arrivava subito “ma che facite, mo’ ve mettit’a pazzià, chiru lunzul quann’avita fernì?”
M: La stessa cosa succedeva anche a me, perché devi sapere che a quei tempi i veri valori di una donna erano saper cucinare, saper cucire, saper mantenere la casa, ricamare, lo studio non era proprio previsto. Io ho sempre amato leggere e studiare ma non appena mia mamma mi vedeva con un libro o un giornale in mano, vedeva il diavolo
A: Anch’io per leggere un poco mi dovevo nascondere. Io non so fare niente perché secondo me ero portata per studiare, ero portata soprattutto per l’aritmetica.
C: Pure mia mamma mi dice sempre che mia nonna la chiamava a mata fissa quando si nascondeva per leggere…
M: Poi dovevi imparare a cucire, dovevi fare la scuola di taglio perché dovevi anche saper tagliare.
Io sono diventata maestra di nascosto da mio padre, tenevo la quinta elementare. Zio Michele (Padre Michele, lo conosci) mi portò a Portici a fare l’esame da privatista e presi la licenza media, poi volevo continuare, ma i miei non volevano. Ho preso il diploma magistrale facendo 3 anni in uno e poi andai a frequentare l’ultimo anno, perché alla fine i miei si convinsero. Poi mi sono potuta diplomare anche grazie a mio marito, che mi aiutava col latino… Per dirti, noi studiavamo di nascosto.
Per tornare all’infanzia, pure io seguivo il nonno nell’orto e ho impresso il ricordo di un lungo bastone di ferro con cui noi, piccolissimi – quattro, cinque, sei anni -, andavamo a infilzare le foglie di limone. Si faceva questa cosa piena di foglie di limone che poi, dopo, si mettevano ad asciugare e si davano ai conigli. Noi abbiamo giocato sulle piante di limoni, salivamo, scendevamo. Poi, all’epoca, non si sprecava nulla. Per esempio, mangiavamo le albicocche, pestavamo i noccioli e ci facevamo il latte di mandorle (lo chiamavamo così, anche se non era di mandorle).
A: Sì, è vero, non si sprecava niente. Un altro ricordo della terra di una volta per me è legato a quando si faceva la vendemmia: prima, qui a Procida, c’erano delle viti alte alte che ora non ci sono più.
C: Anna, in che zona di Procida era questo orto con le viti alte alte?
A: Mio padre teneva un orto fuori alla Panoramica, che era fertilissimo, c’era di tutto e di più: dai gelsi alle albicocche, ci stava il ben di Dio ed era molto, molto fertile.
M: Poi, diciamo, prima l’agricoltura era anche un fatto corale: noi facevamo bottiglie di pomodori, marmellate ed era veramente una festa stare tutti insieme..
C: Invece, Maria, l’orto di tuo nonno era sempre alla Chiaiolella?
M: Sì, a via Rivoli. Prima era un orto che arrivava alla zona delle parule: si partiva da via Rivoli e si arrivava giù al mare. Lì c’era il contadino Scartocchio – così veniva chiamato – che oltre a essere un ottimo contadino, era anche un indovino… Indovinava il futuro e poi toglieva i porri.
Poi, all’epoca, i contadini avevano un rapporto quasi simbiotico con le bestie, soprattutto con gli asini. Di Scartocchio mi ricordo anche la ferocia, perché picchiava il suo asino a morte, diceva che era pigro, non voleva camminare. Ho scritto un altro racconto che si chiama La noria, in cui si parla di questo asino che veniva picchiato dal padrone. T’aggia fa leggere.
E niente, poi adoravo a pischera: l’acqua fresca che usciva dal pozzo. Il momento clou era quando, dopo che l’asino, poverino, a furia di botte, aveva riempito tutta la cisterna – c’era tutto quel sistema con le famose catozze che salivano e scendevano – si toglieva il tappo: era un momento di festa straordinaria, com’era bello, ci mettevamo tutti quanti là con le barchette, i pezzi di legno. Poi quest’acqua arrivava dappertutto. Che sistema di irrigazione che avevano, straordinario!
A: Con l’asino io invece ho un brutto ricordo. Un giorno, il nostro asino non lavorava e stava legato per il basto e io a un certo punto mi allontanai per una passeggiata e lui iniziò ad attorcigliarsi, attorcigliarsi. Io ero piccola e non avevo messo a fuoco il pericolo per l’animale, quindi continuai la passeggiata. Quando tornai, papà mi disse “ma che è successo? È morto l’asino! Si è strangolato! Tu perché non mi hai chiamato?” Poi non ricordo bene come andò a finire, ma mi rimase un senso di colpa.
M: Invece io ricordo che a nonna Pasqua piacevano i fiori. Anch’io adesso amo i fiori perché andavo appresso a nonna in giardino. Nonno invece diceva “i ciure nun te rann’a mangià” [ride] Quindi nonna metteva le piante e il nonno gliele toglieva. Nonna metteva le piante e il nonno gliele toglieva. Mamma mia!
Degli orti come quelli di una volta oggi c’è ben poco. Forse qualcosa in più è rimasta lì nella zona del Cottimo o del cimitero. Ad esempio ci sta Eduardo in quella zona, lui e i figli hanno cura dell’orto, fanno ricerca del prodotto naturale.
A: Invece, nella zona dell’orto di cui ti ho parlato io, adesso hanno cementificato tutto. Quello era un orto d’oro: ci stavano le olive, c’era proprio ogni ben di Dio.
M: Diciamo che non si è capito come questi orti si sono andati perdendo. Poi Procida comunque è un paese di marittimi. L’orto viene sempre in secondo ordine secondo me.
A un certo punto c’è stata una cementificazione selvaggia, con conseguente distruzione degli orti, dei giardini.
Adesso si potrebbe tornare indietro, ma la vedo un po’ difficile.
A: Poi i giovani della mia epoca, come i miei fratelli, ad esempio, sono andati a navigare, non hanno voluto lavorare come agricoltori perché si faceva tanto ma si guadagnava poco. Questo è stato il problema.
C: Sì, anche con mio padre è successa la stessa cosa.
Invece la Chiaiolella com’è cambiata nel tempo e poi come, in questo cambiamento, si è venuta a inserire la vostra associazione di cui Anna è stata anche presidente?

M: Allora la Chiaiolella, ai tempi nostri, era un paradiso. Era veramente straordinaria per i panorami, per tutto.
Il doppio elemento terra-mare, un anno, in una festa, lo mettemmo anche in risalto – ti ricordi, Anna? – Avemmo un contributo dalla regione e presentammo un progetto chiamato “La Chiaiolella tra Cerere e Venere” che metteva l’accento su questo doppio rapporto.
Un tempo c’era tutta la fascia delle parule, appunto, che era un terreno fertilissimo e meraviglioso, senza confini, senza cancelli, perché prima era tutto in comune, era tutto aperto, non come adesso che è tutto recintato. Poi c’era il mare con le zaccalee e i pescatori, quindi per noi ragazzi era un luogo veramente straordinario. Adesso, purtroppo, si dà ampio spazio al turismo – per carità, la mia famiglia è stata la prima insieme a Pasqualino il Lido a capire l’importanza del turismo e a trarne beneficio. Poi il porto della Chiaiolella, per esempio, oggi è occupato da ben 6 affittuari – come si chiamano – con delle barche. Diciamo che a un certo punto non si è capito quello che stava succedendo, sono state date tutte queste concessioni, per carità non voglio criticare, non sono nessuno per dire che è stato sbagliato, però da allora, diciamo, si è vista molta gente in più, tante barche in più, tanto turismo in più, però anche tanto inquinamento. Le parule sono ormai sparite. Rimane quella di Alessandro, di cui abbiamo già parlato, il figlio di Nicola Mesafemmen, che ancora ci tiene. Certe parule sono piene di sterpaglie. Addirittura, nella zona del lungomare, si parla di rifiuti tossici: i terreni sono stati inquinati da tutti questi residui. Una nostra socia ha lottato molto affinché i cantieri abusivi del lungomare venissero smantellati. Ha protestato praticamente da sola e non è stata neanche capita. Però, voglio dire, noi se dobbiamo fare il turismo, lo dobbiamo fare come si deve, sistemato, in sicurezza, facendo leva soprattutto sugli aspetti salutistici, sulla natura, sul rispetto delle regole, sulla valorizzazione del territorio, non distruggere, non ha senso così.
Quindi la Chiaiolella è cambiata, secondo me non in meglio. Poi aggiungiamo che è stata anche molto trascurata dalle precedenti amministrazioni. Quando io ero ragazza la Chiaiolella era l’unico molo turistico della zona, poi, man mano, con il passare del tempo, è andata sempre più indietro, sempre più indietro, non lo so perché, forse per la poca attenzione, per la poca cura del territorio, pochi eventi si facevano, anche per questo è nata la nostra associazione, un momento di ribellione, un momento di dire con forza guardate, ci siamo pure noi della Chiaiolella, siamo in una rete, per carità, nessuna lotta di quartiere, però dateci un po’ di attenzione in più.
A: L’associazione è nata nel 2006.
M: Fummo addirittura derisi quando portammo il bancomat “che dovete fare col bancomat?”, ci dicevano. Abbiamo anche lottato per la farmacia.
A: Sì, abbiamo lottato per tante cose. Noi volevamo che la farmacia ci fosse fissa, ma ci voleva un tot di abitanti, quindi, per un periodo, l’abbiamo avuta solamente per l’estate, perché d’estate si arrivava al minimo di abitanti necessari.
M: Ci siamo battute anche per le spiagge, perché le spiagge libere sono sempre più risicate. Però quando noi andavamo in comune spesso non ci capivano proprio. Ricordo uno dei precedenti sindaci, ci diceva che noi avevamo le spiagge libere più lunghe. Lui intendeva tutta la zona dopo i Faraglioni, che all’epoca era pure franosa, come adesso, del resto. Quindi c’è stato un peggioramento forte della Chiaiolella, e questo mi dispiace, perché secondo me è una delle zone più belle dell’isola.
A: Questo peggioramento ci ha dato la spinta per creare l’associazione.
M: Sì, abbiamo detto “facciamoci sentire!”. Poi abbiamo fatto tanti eventi, adesso non li ripetiamo più, perché ormai la burocrazia è diventata troppo macchinosa. Però abbiamo fatto Cortili in musica, feste della Zucca. Poi, insieme alla Chiesa, abbiamo organizzato Benvenuta estate. Le feste del Carciofo, per la valorizzazione del prodotto locale.
Ora non è più come una volta: per me c’è stato un peggioramento. E c’è stato un aumento di turisti. Sempre più turisti, sempre di più.
A: Sì, stanno venendo molti turisti a Procida in generale. Alla Chiaiolella forse un po’ di meno in proporzione al resto dell’isola ed è una zona che continua a essere molto apprezzata da chi viene da fuori.

M: Però sono i ragazzi che si stanno impegnando, eh. Per esempio, quest’estate, sul Lungomare, c’è stato il Casotto che ha capito bene cosa si poteva fare. Il posto è piccolo, però riesce a essere in armonia col territorio e a soddisfare le esigenze dei turisti.
A: Negli ultimi anni si sono create molte realtà legate al cibo, tutti questi posti piccolini ma che funzionano molto bene.
M: Poi c’è stato il Paradise, che ha attirato tanti ragazzi. Crescenzo, che comunque continua ad avere un posto di prim’ordine, Girone, un punto di riferimento sul Lungomare. Poi quest’estate, proprio sul Lungomare, si è aperto questo locale ricreativo, Cynara – già il nome è molto bello, dedicato al carciofo.
Si trova all’interno delle parule. Insomma, vedo che i ragazzi vogliono valorizzare il territorio, speriamo che ci riescano.
C: Poi c’è l’associazione di kayak…
M: Sì, l’associazione di kayak, tante cose. Ci sono gruppi di ragazzi che portano i turisti a fare il giro in barca. Tante belle realtà, insomma, a volte non valorizzate quanto si dovrebbe.
C: Cambiamo argomento. La scrittura e la cucina sono entrambe alchemiche e allo stesso tempo artigianali. Non è facile cucinare e tantomeno lo è scrivere. Cosa accomuna queste due arti?
M: Questa è una domanda difficile. Per esempio io cucino volentieri e scrivo pure volentieri. Scrivere però è difficile. Ogni tanto ci provo a mettere giù qualcosa e non è assolutamente facile. Mi riescono bene i racconti brevi. Mo’, per esempio, sto scrivendo un piccolo testo, un piccolo romanzetto, molto alla mano. Vedo che è difficile. La scrittura è difficile.
Così come cucinare. Cucinare non è facile, perché bisogna avere cura, attenzione per la materia prima, concentrazione. Per esempio io sono una schiappa totale nei dolci, perché con i dolci bisogna essere precisi – e misura, e fai, e questo e quello.
Invece io, venendo dal ristorante – mi ha insegnato mia mamma a cucinare, nel ristorante – sono più per il salato, dove non c’è bisogno di tanta attenzione.
Anche il sale lo dovresti pesare, ma mamma lo faceva con le mani, a occhio.
C: C’era una signora brasiliana centenaria, su cui i figli (cantanti famosi) hanno scritto un libro di cucina. Lei, quando i figli le chiedevano quanto sale mettere in una sua ricetta, diceva “figlio mio, il sale è un dono!” e il titolo del libro, che esiste solo in portoghese, è proprio Il sale è un dono, perché è un dono sapere quanto sale devi mettere in una pietanza.
M: Sì, è un dono, quindi non è facile. Cucinare è anche un atto d’amore verso la tua famiglia, verso gli ospiti. Quando vengono gli ospiti, invece di preparare pane e salame fai vedere la tua bravura, cerchi di portare il meglio in tavola, lo organizzi bene.
Anche scrivere può essere considerato un atto d’amore, perché è dare un po’ di se stessi nella scrittura, non è una cosa facile, assolutamente, però è bello perché ti riempie e ti arricchisce.
C: Questo mi fa collegare all’altra domanda: la letteratura e la cucina nascono anche come atto relazionale, come richiesta di ascolto. Come farsi ascoltare oggi?
M: Eh, diciamo che oggi, nell’epoca dei social, nell’epoca degli influencer, che praticamente hanno un modo di fare completamente diverso dal nostro, c’è molta superficialità, modi appariscenti che non sentiamo per nulla nostri. Però, se una persona è vera, alla fine riesce a farsi ascoltare. C’è per esempio Benedetta Rossi: in lei traspare l’amore per la cucina, per le tradizioni, la famiglia. Secondo me il segreto è cercare di non legarsi troppo a quello che vogliono gli altri, ma essere se stessi. Non è facile farsi ascoltare, lo so… Però aggio fatt na bella storia sulla marmellata e aggio avuto quasi tricient visualizzazioni. Era su come si fa la marmellata di pompelmi. Mentre la stavo preparando, è venuto mio genero e ha detto “faccio un video” e amm fatt a storia.
C: In realtà io ho qualche difficoltà con la parola “storia” ultimamente…
A: Quello che abbiamo detto fino a ora è Storia….
C: Sì, esatto, è Storia. Storia vuol dire anche raccontare, raccontare a voce o per iscritto in un tempo dilatato. Invece, con l’appropriazione della parola “storia” da parte dei social, adesso si ha la tendenza ad associarla quasi di immediato a quella di instagram o facebook, che ha una temporalità molto più esigua ed effimera…
M: Sì, la storia dei social dura 24 ore e poi sparisce. Non lascia traccia, è una cosa brutta, perché la storia finisce per essere legata a una cosa effimera, non a una cosa che dura, a un ricordo.
C: In che modo la letteratura può ridare carattere di peculiarità e anche una certa sacralità alla cucina?
M: Ho letto diversi libri di scrittori che hanno dato un posto importante alla cucina nella loro opera. Isabel Allende ha fatto tutto un libro di cucina, ad esempio. Anche l’editore di Storie e Sapori dell’isola di Procida non ha voluto solo racconti: doveva esserci un nesso tra la ricetta e il racconto. Adesso, invece, ci sono tanti programmi televisivi in cui i cuochi sono in competizione, si maltrattano le persone che cucinano, non c’è nulla di sacro in questo. Invece cucinare deve essere creazione e anche amore.
La cucina oggi è spettacolo: chi urla, chi strepita, chi maltratta i concorrenti. Non c’è nessuna sacralità.
A: È vero, poi tutti fanno un po’ le stesse cose, non c’è nessuno che spicca.
M: Invece io, oltre ad avere imparato tanto da mia mamma in ristorante, ho avuto un’altra formazione, da mio fratello Giovanni e da sua moglie Libera, che avevano Il melograno a Ischia, dove c’era un’estrema attenzione per la cura del piatto, per la scelta della materia prima. Da loro la cucina aveva davvero un carattere di sacralità: tu ti sedevi nel loro ristorante non solo per mangiare, ma per fare un’esperienza indimenticabile.
C: Adesso una domanda rivolta a tutt’e due: a cosa vi fa pensare l’espressione “Amma cucenà”?
M: È un dovere e un amore e a un certo punto ia cucenà pe’ forza, anche se in altri Paesi non esiste questo dovere: comprano roba già fatta. Mi ricordo che tu dicevi che pure tua mamma, parlando con la vicina, a un certo punto si poneva la domanda “amma cucenà, c’amma cucenà?”
C: Sì, poi io, essendomi occupata completamente della cucina durante quest’ultimo Natale perché mamma si è fatta male al braccio, mi sono ritrovata ad esempio con l’incombenza della scarola da lavare. Mia mamma diceva in continuazione “s’adda lavà a scarola!” e io la prendevo con calma “e vabbuò, se mette rent’o lavandino e si lava”, sottovalutando il fatto che la scarola dell’orto è piena di lumache, quindi per lavarla ci vuole un bel po’ di tempo e dedizione.
A: Mamma mia, è vero, le lumache! [ride]
M: Quindi per me amma cucenà è un atto d’amore, dovere e piacere.
C: E per Anna?
A: Mio marito la mattina si alza e dice “Annù, c’amma cucenà?” ‘Na botta in fronte. Mo’ lui cucina e io mangio.
M: Fai bene, brava!
C: Pure mio padre, dopo pranzo, ad esempio, diceva a mia madre “Musera c’amma fa marenna?”
A: Eh sì perché è comm si stamm semp a cucenà. Secondo me adesso sono stanca di cucinare perché prima, a casa mia, c’era sempre la tavola messa: alla mezza dovevano mangiare i bambini, che poi dovevano fare il riposino, poi veniva un mio nipote e all’una e mezza mangiava lui. Poi, verso le due – due e mezza veniva mio marito che doveva prima aspettare l’autobotte, quindi gira e vota la cucina era sempre aperta.
M: Sì, è normale che ci sia stanchezza. Invece per noi Crescenzo (siamo cinque sorelle), cucinare anche quando abbiamo ospiti all’improvviso non è un problema. Per alcune persone è un incubo “c’aggia cucenà pe’ sta gente?” per noi invece non è mai un problema, abbiamo un rapporto con la cucina molto facile, non abbiamo bisogno di grandi elucubrazioni per decidere cosa mangiare. Adesso pure io non ce la faccio, cucino il mezzogiorno, ma poi la sera faccio cose molto più veloci: un passato di verdure, una cosa semplice. Ma cucinare più volte al giorno veramente diventa un dovere e alla lunga può essere stancante.
C: È vero, perché poi da una cosa piacevole si trasforma in una cosa stressante.
A: Sì, io ultimamente ho un po’ litigato con la cucina. Una volta non sapevo fare neanche un uovo sodo, ma poi piano piano ho imparato e ho fatto tante cose. Ho avuto anche tante soddisfazioni, preparavo la parmigiana per le persone che venivano a villeggiare con cui facevamo amicizia, ricevevo tanti complimenti, allora era gratificante.
C: C’è invece un’espressione procidana a cui siete particolarmente legate e perché?
M: Ho scritto il libro sui proverbi, Antica sagacia procidana, e lì ce ne sono tante di espressioni, anche legate al cibo. Allora, una a cui sono affezionata e dove però viene fuori il mio lato dominante è “je so’ mamma e aggia mammià” la diceva mia nonna “sono mamma e devo comandare” e io, quando le mie figlie in passato mi contestavano, la tiravo sempre fuori. [ride]
Nel mio libro ce ne sono davvero tante e le amo tutte, soprattutto quelle legate al mare. Io mi ricordo che con le mie sorelle, per tradurle, stemmo due ore a ridere. Una è “ca tu puozza aunnà, comme aonna lu mare”, significa che tu possa abbondare come abbonda il mare. Sul cibo pure ce ne sono tante, una è “cu riso, n’ora re tiso”, se mangi il riso, dopo un’ora hai di nuovo fame.
A: Io mi ricordo questa “i bagni settembrini fanno bene a putturina”.
M: [ride]
C: Che significa l’ultima parte?
A: Quella che abbiamo tutte… [ride]
M: Mia zia la diceva sempre. Invece mia nonna ne diceva una legata agli aromi, molto bella “prutusina, tiéneme ‘nzine, vasinicola, tiéneme rint’o core, alaccia, tiéneme ‘mbracce”
Un’altra espressione bella legata al mare è “a varca cammina…” com’è?
A: “A varca cammina e a fava se coce!”
M: È un in invito alla pazienza, a stare tranquilli, che le cose che devono accadere comunque accadranno.
C: È molto bella, sono tutte molto belle. Una che mi è venuta in mente da poco è “attacca u ciuccio addò rice u padrone”
M: Sì, ce ne stanno davvero tante! Invece una parola bella procidana è “accucchiulià”, che viene da conchiglia: i bambini si “accucchiuleano”.
C: Una canzone da associare ai momenti di cucina?
M: Allora, si tratta di una canzone tipica della Terra Murata e io, essendo della Chiaiolella, non la sapevo. L’ho sentita nella versione di Concetta Barra. Racconta che la donna più anziana del paese, nel periodo di Natale girava col Bambinello casa per casa per farsi dare la ‘nferta e ognuno dava un’offerta secondo le proprie possibilità economiche: le persone più ricche davano le castagne del prete, le cose più pregiate, quelle più povere davano quello che avevano. Questa canzone fa capire anche la fame che c’era a quei tempi, perché a un certo punto fa “vulesse ca chiuvéssene maccarune, re prète re la via case rattato” invece ora la pasta la eliminiamo dalla dieta perché ci fa ingrassare, mentre allora era un cibo molto richiesto “re prète re la via case rattato e l’acqua re lu mare vin’annevato” le pietre in strada formaggio grattugiato e l’acqua del mare vino freddo.
C: In effetti è una canzone molto bella, molto evocativa.
M: Sì, fa capire la fame che c’era a quei tempi. Mia nonna mi raccontava che quando mamma si sposò – aveva 16 anni, quindi nel ‘46 – dopo la guerra, in un periodo di fame atroce che avevano vissuto i procidani perché non c’erano collegamenti, non arrivava niente – la farina e queste cose qua da noi arrivavano da fuori. Fecero un po’ di festicciola e a via Rivoli il nonno preparò degli ziti al sugo… ma che arrivò a tavola! Tutti rimasero estasiati da questa pasta, perché non la mangiavano da chissà quanto tempo.