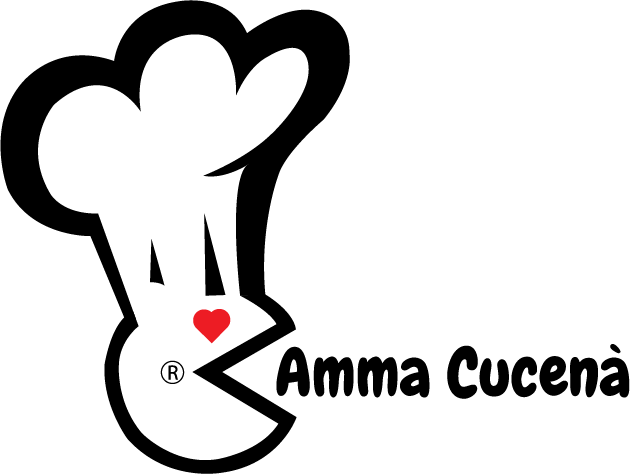Eravamo un gruppo di 13, tutti francisi e io. Una volta arrivati, c’era qualcuno del posto ad aspettarci, quello che sarebbe stato la nostra guida. Eravamo atterrati a fine mattinata all’aeroporto di São Vicente. L’aeroporto di Cesária, sull’isola di Cesária. Non conoscevo nessuno. Mi era familiare solo lei. Cesária.

Sull’aereo avevo chiacchierato con le mie vicine di posto, due signore di Tolosa che andavano a Capo Verde col mio stesso pretesto: camminare. Le ragioni dei nostri percorsi insulari erano sicuramente diverse, ma non lo avremmo mai saputo. Loro erano con un altro gruppo. Nei giorni che seguirono il volo, le incontrai di nuovo per caso per le strade di Mindelo, poi sul traghetto per Santo Antão. Ci sorridevamo, ci salutavamo, spesso e volentieri ci fermavamo a parlare. Poi tornavamo ognuna alle proprie camminate, ai propri gruppi, ai propri percorsi. Sull’aereo avevo avuto il privilegio di stare seduta lato oblò. Descrivevo per le mie vicine l’oceano e i pezzi di deserto spuntati dal nulla all’improvviso. Ogni tanto mi spalmavo sulla sedia per dare un minimo di agio alle affacciate della signora più vicina, che provava a identificare un lembo di terra, una montagna estemporanea.
Viaggiare mi è sempre piaciuto. Abitudine, forse, ereditata da mio padre. Il piacere degli spostamenti è un simbolico zaino che mi porto addosso fin da piccola.
Un’espressione procidana definisce la circostanza in cui una donna fa visita al compagno/marito, di professione marittimo, sulla nave dove è imbarcato. “E gghiut a bord ‘o marit”*, si è sempre detto, si dice ancora. Ebbene, mia madre, quando andava “a bord ‘o marit” per porti italiani, portava sempre anche me e mio fratello. La domanda non si poneva neanche. Non appena scattava l’invito, noi piccoli eravamo già inclusi nella spedizione. Ricordo i porti di Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Milazzo, Augusta, Siracusa. Rivedo nella memoria lance che venivano a prenderci sul molo alle 5 del mattino d’inverno e ci portavano su una petroliera in rada, ingoiata dal buio e dalla nebbia. Mi pare di scorgere ancora la sagoma del bastimento sempre più nitida man mano che ci avvicinavamo. Per salire a bordo c’era una biscaglina o una passerella tra la lancia e la nave, che io all’inizio attraversavo sempre in braccio a mio padre. Arrivati in cima, lui passava il carico della figliolanza alle braccia di un marinaio appostato sul metallo dell’imbarcazione gigante. Salire la biscaglina traballante da sola, col passare degli anni, voleva dire diventare sempre più grande. Ricordo lo stretto di Messina attraversato da un treno smontato, sistemato a pezzi su un traghetto e rimontato sull’altra sponda. Altra operazione delle 5 del mattino… Volevo essere sempre svegliata da mia madre per assistere a tutto quel ferraglioso smont e ammont e guardare Messina sempre più vicina dai finestrini del traghetto.
Quando viaggiavo da piccola era fondamentalmente per andare a trovare qualcuno. Nei viaggi di ora, la sensazione è un po’ la stessa, anche se non mi muovo sempre per andare a trovare qualcuno. I viaggi più belli, per me, sono quelli in cui ritrovo il familiare nello spaesamento, nei posti dove non conosco nessuno. Capo Verde è stato uno di questi posti.
La prima sera lì, la guida ci mise in cerchio, tipo alcolisti anonimi e ci chiese perché avevamo deciso di visitare le due isole dell’arcipelago. Svariate furono le risposte. La mia: “io sono qui per la musica. Poi per vivere un minimo l’insularità di qua. Poi voglio sempre assaggiare la cucina locale…”.
Piatti a base di pesce: cosa prediligere
Mio padre, quando gli dissi che avevo in programma di andare a Capo Verde, mi raccomandò vivamente di mangiare piatti a base di pesce, vista la generosità del mare locale. Aveva ragione. Bastava fare un giro al mercato del pesce di Mindelo per capirlo.

Il primo giorno a Mindelo, nel cuore del pomeriggio, ci ritrovammo su una terrazza coperta a tratti da tettoie di legno, a tratti da ombrelloni rossi della coca-cola. Un bar ristorante senza grosse pretese. Per accedervi bisognava salire una scala, quindi, dalla strada non ci era dato sapere se il posto fosse frequentato. Papà diceva sempre che “Quann nu ristorant sta iss e i tavulin, n’s mang buon”**… Per fortuna, questa validissima regola, non si applicava al Restaurante, Pizzeria, Bar-Café, Showarma, Fast-Food “O Cocktail”, sempre pieno, soprattutto di gente del posto, e che finì col diventare il mio angolo preferito a Mindelo per rifocillarsi, nonostante le perplessità iniziali suscitate da quel “Pizzeria”, per non parlare del “Fast-Food” annoverato nella lista dei servizi proposti dal locale.
Tavolata pomeridiana, quindi, con la maggior parte del gruppo e la guida. In aereo avevano distribuito il pranzo e un dessert industriale, la baba de camelo. Seppur confezionata, la bava di cammello rimaneva e rimarrà il mio dolce portoghese preferito. Ovviamente prediligo la versione fresca, fatta a base di uova crude e latte condensato. Avrò modo di riparlarne, magari postando la ricetta. Fatto sta che la baba de camelo mi aveva talmente riempita, da non farmi sentire fame nel cuore del pomeriggio, nonostante le 4 ore di fuso orario ci portassero quasi a ora di cena. Mi limitai a un succo di frutta. Iniziai a osservare le affinità del menù capoverdiano con quelli portoghesi: l’acqua minerale più in voga, lì, era la “Água das Pedras”, proprio come in Portogallo. Un’altra assonanza con quello che si può trovare in un ristorante portoghese era l’arroz de polvo, ordinato da uno dei francisi. Un signor arroz de polvo, con una bellissima faccia e un odorino che ti apriva lo stomaco.

Quando rientrammo a Mindelo per lasciare Capo Verde, tornai al Cocktail per assaggiarlo. Si trattava, però, ancora di qualcosa che mi ricordava il Portogallo. Ne ero quasi infastidita. Non era quella la familiarità che cercavo. Mentre mi preparavo al viaggio, avevo fatto ricerche per capire cosa fosse veramente tipico nella cucina capoverdiana, a parte la cachupa. Ero capitata sul pudim de coco e sul pudim de queijo*** nella parte dei dolci. Mi ritrovai a condividere l’informazione con due signore del gruppo, che avevano più fame di me e ordinarono una fetta di pudim al cocco. Ne furono entusiaste, mi proposero di assaggiarlo, ma avevo ancora un fantomatico cammello sbavacchiante sullo stomaco e volevo lasciare posto all’appetito della sera di cena locale. Il pudim (di cui ho già parlato qui) diventò una costante delle allegre tavolate capoverdiane e non mancò occasione per assaporarlo più volte.

Qualche ora dopo, cenammo in un posto con vista sulla baia di Mindelo, ma con piatti meno invitanti del “Cocktail”. Anche in quel caso, mi ritrovai a essere ascoltata sui consigli su piatti da scegliere. C’era chi ordinò un banale pollo arrosto e chi volle provare piatti a base di pesce. C’era uno spiedino di calamari, da me vivamente sconsigliato: quando lo vidi sul menù, con tanto di foto, storsi il naso…. “Il calamaro forse un po’ vecchio, l’avranno impupacchiato con aromi vari e adibito a spiedino”… una strana trasformazione. Meglio andare sulla semplicità di una bistecca di tonno grigliata, che poi si confermò essere valore sicuro delle tavole capoverdiane. Una coppia di Annecy e un’altra signora della Normandia seguirono a ragione la mia intuizione: chi aveva ordinato lo spiedino di calamari non riuscì a finirlo.

Da allora, ogni volta che ci ritrovavamo a dover ordinare un pasto, mi chiedevano sempre consigli, soprattutto sui piatti a base di pesce. La mia procidanità fu un marchio di garanzia per districarsi con le ordinazioni.
Il cuscuz de milho
Il giorno dopo cambiammo isola. Da São Vicente, ci spostammo a Santo Antão, l’isola più occidentale dell’arcipelago, con un’ora di traghetto mattutino, solcando le onde dell’oceano. A bordo ci piazzammo tutti all’esterno.

Non volli rinunciare a un posto a prua, in alto, in piedi, nonostante le onde grandi, il vento in faccia e l’equilibrio precario: pescetti per fortuna infotografabili volavano veloci sull’acqua, bestioline mai incontrate prima sui mari che ero abituata a navigare. Non potevo perdere lo spettacolo.
Arrivati sulla nuova isola, ci fermammo a comprare acqua e frutta per accompagnare il pic-nic del pranzo. Ci dirigemmo poi verso il cratere di Cova, in un vulcano estinto dell’isola, vallata dalla vegetazione piuttosto mediterranea.
A un certo punto, mentre risalivamo una strada asfaltata partita da uno dei sentieri che si diramavano dal cratere sotto il sole cocente, ci sembrò di avere un miraggio. Una giovane donna, con un chioschetto spuntato dal nulla, fatto di un ombrellone di paglia e un tavolino sgangherato, vendeva confetture, tisane, dolci.

Tutto fatto in casa con prodotti del posto. Tra bottigliette, barattoli di vetro, tazze e tazzotti, c’era anche il tipico grog. La sosta fu d’obbligo. Comprammo dolci che poi ci scambiammo e soprattutto tisana. Una calda, piacevole bevanda infusa di un’erba aromatica locale che non riuscimmo a identificare, molto rifocillante per continuare la lunga camminata. Ci fu chi non rinunciò a un sorso di grog. Io mi soffermai su un dolce giallo tradizionale che non avevo mai visto prima, il cuscuz de milho, preparato con farina di mais e cotto al vapore in un recipiente di argilla speciale (binde), di per sé poco dolce, servito con burro o melassa di canna. Assaggiai la versione con la melassa.

Pare si tratti di un dolce di origine dell’Africa continentale, sconosciuto nella penisola iberica prima della fine della conquista portoghese, sicuramente introdotto a Capo Verde tramite le usanze alimentari degli schiavi provenienti dal continente africano****. La parola per definirlo ricorda il cuscus del Maghreb (di cui in Europa si aveva avuto traccia per la prima volta in un libro di ricette dell’Al Andalus*****), della Sicilia occidentale o della Sardegna sudoccidentale, ma a differenza della forma a granelli sfusi, questo dolce si presenta compatto, come una specie di piccolo panettone. Il nome dell’utensile per prepararlo ci riporta a un legame diretto con la cucina senegalese: “Binde” è infatti una parola wolof (lingua parlata principalmente in Senegal, geograficamente non lontano dall’arcipelago, in Mauritania e in Gambia). Una variante simile al dolce capoverdiano, per colore e forma, è un dolce tipico del Nordest, in Brasile. All’arrivo dei primi portoghesi nel 1456 le isole di Capo Verde erano completamente disabitate. I primi insediamenti umani scaturirono dall’arrivo di coloni portoghesi e di schiavi provenienti dalle coste occidentali dell’Africa, soprattutto con la fondazione della prima città nel 1462, Ribeira Grande, sull’isola di Santiago (oggi Cidade Velha). L’arcipelago diventò successivamente anche scalo per la tratta degli schiavi diretti verso l’America (principalmente verso il Brasile). Forse è dovuta a questo la somiglianza del dolce capoverdiano con quello nordestino. Assonanze nella distanza, cicatrici storiche trasformate in un cibo, una lingua e una musica propria, fanno di Capo Verde una costellazione di isole sull’oceano che influenza e si fa influenzare, creando realtà tutte sue, mostrando una forza catartica espressa soprattutto nel canto delle sue voci più autorevoli (Cesária Évora, ma anche i Tubrarões, Tito Paris, Ildo Lobo, Paulino Vieira o i più giovani Mayra Andrade, Sara Tavares, Elida Almeida, Dino D’Santiago, solo per citarne alcuni).
L’aragosta va mangiata con le mani e solo in alcuni periodi dell’anno
Nel tardo pomeriggio giungemmo al villaggio dove avremmo alloggiato due notti, Ponta do Sol, praticamente dal lato opposto dell’isola. Sulla strada per arrivare e una volta giunti a destinazione, mi misi a osservare la differenza tra le case dipinte e quelle grigie, rimaste ancora grezze.

Una studentessa capoverdiana, qualche mese prima del viaggio, mi aveva spiegato quanto fosse importante per gli isolani emigrati costruire una casa sulla propria isola e finirla col tempo, man mano che si accumulavano risparmi e soggiorni insulari, principalmente estivi. Quelle costruzioni grezze legittimavano il legame indissolubile tra la diaspora e le presenze intermittenti sulla propria isola per costruirsi una radice nella radice, un’isola sull’isola. Le fondamenta erano state scavate. La “prima pietra” era stata posata. Si poteva ripartire con una sodade attenuata e si aveva un motivo in più per ritornare.
La sera cenammo in un posto con pochissimi tavoli, in cui praticamente c’eravamo solo noi e avemmo la fortuna di assaggiare una vera prelibatezza del posto: l’aragosta appena pescata. Se si viaggia a Capo Verde, va ricordato che la pesca e la vendita delle aragoste è vietata durante tutto il periodo estivo, da giugno a ottobre, arco di tempo in cui le aragoste si riproducono. Questa “pausa” consentirebbe di dare alla specie ulteriori possibilità di sopravvivenza. Va detto, però, che il fermo biologico non sempre viene rispettato da pescatori e ristoratori, visto che il paese non ha molti mezzi di sorveglianza. Sta quindi al cliente avere il buon senso di evitare di incoraggiare il consumo di aragoste nel periodo di divieto di pesca e commercio. Da giugno a ottobre, quindi, dimenticare il prelibato crostaceo e concentrarsi piuttosto sulle altre, numerose alternative offerte dal mare locale!******
Noi avemmo la possibilità di mangiare l’aragosta il 29 aprile. Ce la servirono condita con un leggero tocco di cipolla e pomodoro, accompagnata dai “ferri del mestiere” per aprirla.

Per contorno, vennero disposte sulla tavola 3 sperlunghe con insalata verde e con patate, patata dolce, manioca e igname, tutto cotto al vapore. Queste verdure erano sempre presenti per accompagnare quasi tutti i piatti assaggiati ed erano sempre freschissime: anche i capoverdiani, come i procidani, possono essere “figghie ra zapp e/o ru rimm”*******. Non appena il crostaceo ci fu servito, la guida ci incoraggiò calorosamente a mangiarlo con le mani, soprattutto perché i tentativi di apertura con i soli ferri del mestiere, provocavano improvvise schizzate di sughetto sui vestiti di chi stava di fronte. Grande mangiatrice di pizza e cicaredde (canocchie) con le mani, non mi feci ripetere l’incoraggiamento due volte. Progressivamente e non senza reticenze per alcuni, anche i francisi cominciarono a dare ascolto alla guida e ci ritrovammo tutti a mangiare con le mani e a fare a gara a chi riusciva a spolpare con più minuzia l’aragosta capitata a tiro. Tra l’imbarazzo di mangiare con le mani e quello di inguacchiare gli abiti del vicino, il secondo ebbe la meglio.
La cachupa del 1°maggio
Ne avevo già parlato nel post dedicato al pudim: a pranzo, andavamo spesso a casa di persone del posto. C’erano signore che cucinavano per tutto il gruppo e ci aspettavano a mezzogiorno con una tavola imbandita, per lo più nel cortile delle loro abitazioni. Non mi è difficile immaginare i discorsi tra queste signore in kriolu, avvisate dell’arrivo di un gruppo di francisi: “riman venen i francis, amma cucenà. C’amma cucenà?” (liberamente adattato al procidano). Il 1° maggio ci ritrovammo dunque seduti a tavola nel cortile della signora Augusta. A fianco alla casa, c’era una bottega di falegname, con un uomo che martellava, costruiva, anche nel silenzio rotto solo dalla musica di una giornata di festa.
Il pasto del giorno sarebbe stato quello tipico di Santiago, ma in realtà piatto nazionale: la cachupa (catchupa o catxupa). Gli ingredienti base di questo piatto sono mais, fagioli, grasso di maiale, carne o pesce e, talvolta, verdure. Quella assaggiata da noi era abbastanza classica, con gli ingredienti principali, carne di maiale, verza, patate, patata dolce, zucca, manioca.

Proviamo a osservare le origini di questo piatto. Fino all’ultimo quarto del XX secolo, la cachupa era il pasto quotidiano delle famiglie povere di tutte le isole dell’arcipelago, sia in ambienti rurali che nei centri urbani. Pare che la creazione di questo piatto risalga almeno all’inizio del XVII secolo, periodo in cui il mais e una varietà di fagioli provenienti dall’America e dall’Africa continentale erano già coltivati sulle isole di Santiago e Fogo e si diffusero sulle altre isole nel processo dei rispettivi insediamenti umani. Il fatto che la cachupa sia un elemento identitario di tutte le isole abitate, dimostra la sua antichità nel contesto della storia dell’arcipelago. A Santiago e Fogo si registrarono i primi insediamenti umani nella seconda metà del XV e agli inzi del XVI secolo. Le altre isole, invece, avrebbero consolidato il proprio popolamento tra il XVII e XIX secolo. La cachupa avrebbe quindi accompagnato il popolamento delle isole nella seconda fase di colonizzazione dell’arcipelago, passando di isola in isola. La cachupa ha poi seguito la diaspora in tutti i paesi in cui vivono comunità capoverdiane.********
Per un sorso di grogue
Durante il nostro soggiorno a Santo Antão, visitammo una fabbrica artigianale di grogue, il distillato tipico di Capo Verde, nella valle di Paul, zona dalla vegetazione ricca di piantagioni di banane, canna da zucchero, igname. La nostra camminata mattutina fu ritmata dai sorridenti e ricambiati “bom dia” rivolti a tutti i tagliatori di canna da zucchero all’opera incontrati sui lati dei sentieri attraversati, mentre mi risuonavano nella testa canti appresi in qualche anno di capoeira e che parlavano del gesto ancestrale di “cortar cana” (come questo).

La canna è raccolta quando è ancora in fiore, tra marzo e giugno. Noi vedemmo fare questa operazione a fine aprile-inizio maggio, praticamente nel pieno. Introdotta dai portoghesi con l’avvio della tratta degli schiavi, la canna da zucchero è l’unico ingrediente da usare per la produzione di grog artigianale.
Il Grog, Grogue o Grogu deve essere ottenuto unicamente tramite il mosto fermentato di canna da zucchero, senza aggiunta di zucchero raffinato che diminuisce di molto la qualità del prodotto. Le foglie delle canne vengono tolte e utilizzate per foraggiare gli animali o per alimentare il fuoco dell’alambicco. Le canne vengono poi tagliate, schiacciate e spolpate dai rulli del trapiche, una macina che può essere elettrica o a trazione animale.
L’uomo che guida i buoi nella trazione viene chiamato “falador de bois” (letteralmente “parlatore ai buoi”), perché anticamente usava il tempo passato con gli animali per esprimere verbalmente i propri sentimenti. Altro elemento che ci riporta all’epoca della schiavitù: gli schiavi, non autorizzati a parlare, avevano conversazioni con i buoi durante il lavoro con i rulli del trapiche.
Dall’operazione col trapiche risulta la kalda, uno sciroppo che viene versato e lasciato fermentare in barili di legno. La fermentazione non richiede aggiunta di lievito e dura 12-15 giorni. Nel processo di fermentazione, lo zucchero si trasforma in alcol. In una fermentazione perfetta, tutto lo zucchero diventa alcol.

Terminata la fermentazione, la kalda viene versata nel lambiki, un grande alambicco di rame, che a sua volta viene disposto su un forno di pietra alimentato da fogliame vario di piantagioni del posto e legna. Ha quindi il via la distillazione: i vapori fuoriescono dalla serpentina e si fa scorrere acqua nel condotto utilizzato per il raffreddamento (il koxe). I vapori si condensano sul tubo raffreddato mentre il distillato scorre dall’estremità. Il grog è un prodotto tipico soprattutto dell’isola di Santo Antão. Si tratta di un liquore trasparente molto forte, che io ho difficoltà a bere senza mischiarlo a succhi di frutta (Ponche). Potremmo considerarlo la base del Rum, che sarebbe un grog lasciato invecchiare in botti di legno.*********
Ritorno sull’isola di Cize
Dopo aver macinato vari chilometri per le montagne e le vallate di Santo Antão, facemmo ritorno a São Vicente, sempre in traghetto, con la corsa di un fine pomeriggio. Habituée dei traghetti tra Procida e la terraferma (o Ischia) praticamente da quando sono nata, rimasi colpita sia all’andata che al ritorno dalla ferrea organizzazione per l’imbarco e lo sbarco di persone e autoveicoli. A differenza di quanto succede praticamente su tutte le linee di traghetti a cui sono abituata nella mia regione di origine, a Capo Verde ho notato una grande attenzione per le persone, fatte imbarcare e sbarcare rigorosamente prima degli autoveicoli e soprattutto da passerelle diverse dal portellone di accesso riservato unicamente ai mezzi a motore. Durante le operazioni di sbarco e imbarco, si respira decisamente meglio e non si è stressati dall’automobile o camion di turno impaziente per trovare parcheggio a bordo o per scendere a terra.
La sera tornammo al Cocktail (dove poi tornai anche da sola) e assaggiai il pudim al cocco della casa.
Avevo programmato un giorno in più sul posto rispetto al resto del gruppo, per coincidere con un aereo che mi avrebbe portata in Italia per poi andare a Procida a trascorrervi il resto delle ferie e a regalare racconti capoverdiani ai miei.

Avevamo salutato già una parte gruppo, partita per proseguire le escursioni su altre isole dell’arcipelago. Eravamo rimaste in sei il venerdì pomeriggio e dedicammo la serata a fare il bilancio del viaggio, a scambiarci i numeri per inviarci su whatsapp le foto scattate e ricordare insieme Capo Verde dalle città francesi. Il tutto, davanti ad altre specialità locali, in un posto carino ma un po’ troppo turistico per i miei gusti (Café Casa Mindelo). Il sabato mattina le altre 5 ripartirono. Mentre facevamo colazione insieme per l’ultima volta, una di loro mi chiese “allora, cosa farai nella tua ultima giornata capoverdiana?” e io “vado al cimitero” Dovetti ripeterlo due volte, scandendo bene la seconda, perché la parola francese cimetière la pronuncio sempre male e spesso si ha difficoltà a capirmi al primo colpo. Lo dissi con una tale solennità, da far sorprendere e sorridere la mia interlocutrice. “A trovare Cesaria Évora” aggiunsi sorridendo a mia volta… “Poi in giro”. Dopo la colazione, salutai le ultime compagne di viaggio e mi avviai alla ricerca della tomba di Cize*********. Il posto dove alloggiavamo era a una ventina di minuti a piedi dal cimitero. All’andata mi dilungai perdendomi per vic e vicariedd e chiedendo informazioni alle persone incontrate. Mentre camminavo, ricordavo i momenti dell’unica volta in cui l’avevo vista in concerto, davanti alla torre di Belém, a Lisbona, nel 2006. Varcata la soglia del cimitero, iniziai a guardarmi intorno per cercare la tomba. Non sapevo proprio da dove cominciare. A un certo punto mi sentii chiamare con un “ei! ei!”. Due muratori stavano facendo lavori di manutenzione del luogo. Era stato uno di loro a interrompere il lavoro per interpellarmi. Quando vide che mi girai e lo salutai con un “bom dia” mi chiese “Cesária?” Annuii con un sorriso malinconico e lui mi indicò la strada silenzioso, con un gesto gentile e secolare, di anfitrione fiero di mostrare la parte più preziosa di casa sua. Grazie a lui, trovai subito la tomba.

Forse, ero venuta a Capo Verde soprattutto per andare a trovare lei, Cize. Cesária.
Lei, che aveva messo scompiglio nella mitologia delle donne delle isole, non più destinate solo e sempre a essere Penelope.
Lei, che ha ispirato la bellissima sovversione di genere e il sacrosanto smantellamento di pretesa supremazia del più celebre dei saluti imperiali.
“Ave Cesária!” In loop. A una donna. A una donna nera. A una donna eterna. Musa, Maestra.

Note e risorse consultate, che riporto per eventuali approfondimenti 🙂
“è gghiut a bord o marit”* : “è andata a bordo dal marito”. Procida è storicamente isola di marittimi. Capitava (e capita) che gli uomini a bordo ricevessero visita dalle proprie famiglie.
“Quann nu ristorant sta iss e i tavulin, n’s mang buon”**: “Quando in un ristorante ci sono solo i tavoli e il personale, vuol dire che non si mangia bene”. Il successo di un ristorante è espresso dal fatto che esso sia frequentato o meno.
“pudim de coco e sul pudim de queijo“***: budino al cocco e budino al formaggio. Si tratta di dolci al cucchiao, abbastanza semplici, con una base di uova e latte condensato.
****Per tutte le informazioni sul cuscuz sono state consultate le seguenti fonti: Cvraiz.com , PT.Wikipedia , Boavista Official per i cenni storici sull’arcipelago . Per vedere il binde, suggerisco di osservare il video sul blog Criola cozinha, ottima risorsa per tutta la cucina capoverdiana. La ricetta proposta nel video è con farina di grano.
Al Andalus*****: è il nome che designa l’insieme di territori della penisola iberica e di una parte del sud della Francia sotto dominazione musulmana tra il 711 e il 1492.
******Tutte le principali guide dedicate all’arcipelago, parlano del fermo biologico per la pesca delle aragoste. Basta consultare Petit Futé, Routard.. Per citarne alcune.
*******“figghie ra zapp e/o ru rimm”: frase liberamente ispirata a un’espressione procidana che ho ascoltato per la prima volta dallo scrittore e medico Giacomo Retaggio, solido riferimento di cultura e storia procidana. “Chi nn ven ra zapp, ven ro rimm” (chi non viene dalla zappa, viene dal remo), usata per dire che a Procida ci conosciamo tutti (per chi volesse riascoltare l’espressione pronunciata dal Dottor Retaggio, può farlo al minuto 52:00 della conversazione organizzata da NNCNewmediacom su Facebook ). Ho riadattato la frase, per dire che i capoverdiani sull’arcipelago sono dediti sia alla pesca che all’agricoltura.
******* Per la cachupa, le fonti di approfondimento sono: Eatout-Caboverde.com , CiberDuvidas.Iscte-Iul.pt (per l’origine della parola “cachupa”). Una piccolo editoriale dello scrittore capoverdiano Germano Almeida sul Diáro de Notícias.
********Per approfondire l’argomento “Grog” (di cui ho usato le diverse ortografie), sono state consultate le seguenti fonti: MadeInCabVerde , FondazioneSlowFood , AfricaIsole.
*********Per un approfondimento sulla figura di Cesária Évora, consiglio la visione del bellissimo documentario Nha Sentimento.