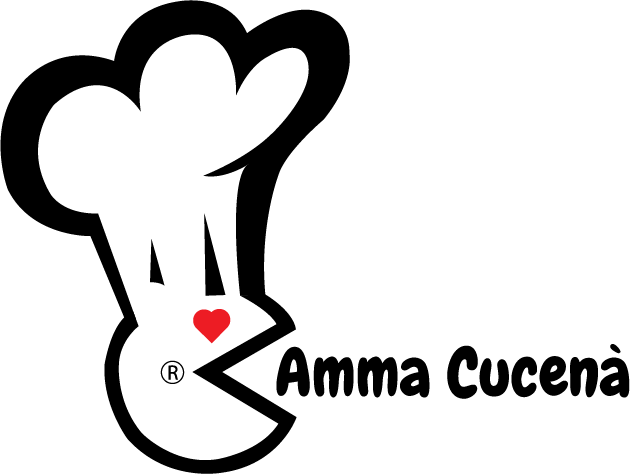Ascoltare Marco Ambrosino, chef procidano del 28 posti (bistrot situato sui Navigli nel capoluogo lombardo), apre una finestra su un ricchissimo ed eclettico universo gastronomico, antropologico, etico. Il giovane dalle solidissime radici procidane, attraverso le sue creazioni culinarie allarga lo sguardo verso e oltre il Mediterraneo, spazio a cui dedica, tramite il collettivo Mediterraneo, un’attenzione e una ricerca tutta particolare, accogliendo plulariltà di sguardi.
Vi invito a leggere la chiacchiarata che ho avuto il piacere e l’onore di fare con lui per cuoc@ nostrom@ di giugno.
Cucinellista: Puoi raccontarmi un po’ il tuo percorso per diventare chef, avendo Procida come punto di partenza e soprattutto cosa ti hanno lasciato tutte le esperienze che hanno preceduto 28 posti, quindi al Melograno di Ischia, al Noma di Copenhagen, da Buongusto a Milano?
Marco: Ho cominciato a lavorare per la prima volta in un ristorante da giovanissimo, a 14 anni, a Procida, all’Agave, quando ce lo aveva ancora Vincenzo. Cominciai per gioco in realtà, mentre ero ancora al liceo. Andammo tutti a lavorare lì, con un gruppo di amici con cui condividevamo già le giornate, lo facevamo come lavoretto estivo. Il caso volle che per me ci fosse un posto in cucina, lavavo i piatti. Dai 14 anni a oggi, poi, non ho mai interrotto questo lavoro in cucina.
Dopo gli inizi lì da Vincenzo, ci fu un’altra casualità: mio zio Michele prese in gestione il Maestrale alla Corricella e un giorno – lui non c’era – per un’incomprensione capitò che non ci fosse nessuno ai fornelli e io mi ritrovai da solo a 15-16 anni a dover cucinare per la gente seduta ai tavoli. Chiaramente, con buone probabilità, mio zio quel giorno perse 30-40 clienti, perché credo di aver fatto diversi disastri… Ma per me fu un’esperienza divertentissima e anche la classica esperienza per cui o non ci vuoi entrare mai più in un ristorante o diventa la tua vita. Poi ho continuato il liceo, ho cominciato anche l’università, ma da lì in poi ho sempre lavorato nei ristoranti, sull’isola fino ai 22 anni. Sono stato tanto tempo al Lido, con Luigi e anche lì è stata un’esperienza bellissima.
A 23 anni ebbi l’occasione di lavorare al Melograno con Libera Iovine e lì ho conosciuto un altro tipo di ristorazione, che non voglio definire migliore, ma sicuramente con un’attenzione diversa. A Procida, soprattutto per i lavoratori stagionali (quindi non per i titolari delle attività) si fanno sempre delle esperienze temporanee, per forza di cose meno approfondite, sull’isola c’è poca gente che fa il cameriere di mestiere, sono sempre delle cose che servono per riempire il periodo estivo. Però le esperienze procidane per me sono state fondamentali, innanzitutto perché ho conosciuto questo mestiere, poi, i primi anni ero giovanissimo, quindi conoscevi la prima autonomia, la prima indipendenza, tornavi più tardi la sera, avevi i tuoi soldi…Tutta una serie di cose che mi sono servite per quello e poi un po’ come corso di sopravvivenza. Oggi, ad esempio, qui al 28 posti abbiamo per l’appunto 28 posti, ne possiamo fare 30, 32, questi sono i numeri, fatti chiaramente con un’attenzione particolare. Ma io ricordo delle domeniche giù al Lido con Luigi dove facevamo 300-400 coperti e lì ne dovevi uscire vivo, quindi per me quegli anni sono stati una grandissima palestra e soprattutto, ripeto, li ricordo come degli anni divertentissimi, mi sono serviti in maniera anche un po’ trasversale per appassionarmi a questo lavoro proprio perché era un grande divertimento. In quegli anni non pensavo di voler fare il cuoco nella vita, quindi lo facevo con ancora più leggerezza dal punto di vista degli orari di lavoro, della fatica e quant’altro… E meno male! Oggi sono felicissimo di questa cosa, perché mi è servita a non odiarlo già da piccolo questo mestiere. Molto spesso, quando inizi a farlo tramite la scuola – per l’amor di Dio ci sono grandi scuole adesso che si occupano di ristorazione – spesso lo fai perché lo devi fare. Invece io lo facevo per piacere, mi divertiva proprio tanto.
Poi, ti dicevo, sono arrivato al Melograno, per me la grande scuola che in realtà non ho mai fatto nelle scuole, perché ho conosciuto un modo di lavorare diverso, ho conosciuto Libera che è stata veramente una maestra in tutto, nonostante noi oggi facciamo cucine completamente differenti e con approcci diversi, ma le cose veramente importanti di questo mestiere io le ho imparate lì. Paradossalmente, il primo rapporto strettissimo con il pesce di Procida io l’ho avuto a Ischia, perché ogni giorno Giovanni andava a recuperare il pesce a Procida e noi avevamo del pesce che due ore prima era in mare, avevamo il problema che il pesce era troppo fresco, che è un problema bellissimo, voglio dire… ad avercelo qua a Milano! Per me quella è stata un’esperienza davvero fondamentale da un punto di vista professionale e poi si è rivelata tale anche dal punto di vista personale perché lì, nel 2007, ho conosciuto quella che poi è diventata mia moglie: lei è architetta, a quei tempi era all’università e veniva a fare gli extra al Melograno e da allora non ci siamo mai più separati.
Dopo l’esperienza al Melograno, in realtà mia moglie era già in giro per l’Europa perché ha fatto l’Erasmus a Barcellona e io ho passato un anno con lei, facendo degli stage lì in Spagna, poi è andata in Portogallo, poi a Siviglia, quindi diciamo che avevamo voglia di andare un po’ in giro.
Poi ho fatto questa esperienza incredibile in Danimarca – molto breve in realtà, ci sono stato circa 2 mesi – dove ho avuto la possibilità di lavorare in quello che veniva considerato il miglior ristorante del mondo. Ero al centro di tutto quello che mi interessa, ma non al centro del paese o della nazione, ero al centro del mondo: lì ho conosciuto gli chef più famosi del mondo, ho incontrato ragazzi di ogni dove. Quando ero al Noma, solo in cucina eravamo 60, arrivati da tutti e 5 i continenti e tante sono persone con cui ancora ci sentiamo, ci scriviamo: un’esperienza incredibile, è stato il mio Erasmus quello lì! Inoltre, ho conosciuto un modo di lavorare in cucina completamente diverso: ad esempio, ero lì a pulire le erbe e di fianco a me c’era una persona che stava facendo lo stesso lavoro, ma che allo stesso tempo stava facendo un dottorato in botanica, in microbiologia. Era un modo di cucinare con uno sguardo più ampio e lì ho percepito che si poteva fare questo mestiere in una maniera diversa: al di là del piatto, degli ingredienti – chiaramente tutte cose non replicabili per il contesto, per l’habitat, per i prodotti utilizzati – però c’era quell’approccio internazionale.. Lì si portava avanti un’identità locale fortissima, ma raccontandola al mondo intero e questa cosa mi è piaciuta tantissimo e me la sono portata dietro e forse è la grande lezione che ho imparato lì.
Quando sono tornato dalla Danimarca, io e Simona, mia moglie, abbiamo deciso di vivere in Italia sostanzialmente. Io non ho mai deciso di andare via da Procida, la dico sempre questa cosa, mi considero sempre un procidano, però, siccome decidemmo di restare in Italia, in quegli anni mi serviva la città più internazionale, più europea che ci fosse in Italia e Milano era una scelta obbligata, come purtroppo lo è ancora: quell’apertura lì ce l’ha ancora solo Milano. Ho cominciato in un piccolissimo ristorante che si chiamava Buongusto (adesso non c’è più) piccolissimo nel vero senso della parola: erano 30 metri quadri compreso di cucina, bagni e deposito, veramente microscopico! Però anche quell’esperienza lì mi è servita, perché ho conosciuto Milano… Prima di allora, c’ero stato solo per un giorno, per un concerto di Pino Daniele. Quindi, per farti capire, il mio rapporto con Milano è stato completamente alla cieca. Ho fatto due anni al Buongusto e poi, per una serie di casualità, ho incontrato i titolari del 28 posti. Loro avevano aperto da meno di un anno e chiaramente, con i soliti casini del primo anno di apertura, in cucina erano cambiati già due chef. Ci siamo conosciuti e ormai sono più di 7 anni che sono qui e va bene, siamo contenti, c’è una squadra bellissima che lavora con me ormai da tanti anni, siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo costruito.
C: In tutto questo, in cosa l’essere procidano secondo te ha potuto rappresentare un valore aggiunto?
M: L’essere procidano per me è fondamentale quotidianamente, poi può sembrare una banalità che uno dice “Procida io la porto sempre nel cuore” però nel mio mestiere, che è un mestiere fortemente legato al ricordo, al rapporto con i prodotti, è veramente così. Il mio è un mestiere di bottega, si impara vedendolo fare agli altri e per me è stato fondamentale il legame con Procida.
Tu lo sai, a Procida nelle famiglie si cucina ancora e quindi il rapporto col fuoco, col fornello, con la padella c’è sempre stato, ce l’abbiamo tutti, pure chi non sa cucinare. Mio padre non sa cucinare, fa solo il caffè, ma ha questo rapporto anche lui in realtà, perché viviamo in famiglie con madri che hanno sempre cucinato, con padri marittimi che cucinavano anche a bordo, che cucinavano molto bene e cucinavano cose particolari. Io ricordo che mio nonno faceva una paella incredibile perché nei viaggi in Spagna si era portato quei sapori. Quindi c’è già quest’approccio con l’atto del cucinare, col momento della tavola, che è momento di ricongiungimento, di resoconto della giornata. E poi ci sono una serie di sapori, di suggestioni che noi, anche in maniera involontaria, ci portiamo dietro. Tu lo sai, vengo dalla Chiajozza, quindi per me il profumo del finocchio di mare, del pino marittimo, del cipresso, dell’unghia di janara, quelle piante che stanno vicino alla montagna, quelle sono cose che ti porti dietro punto e basta. Il riccio di mare sta là, noi non abbiamo mai avuto il problema di cosa farci, perché lo prendevi, lo aprivi e te lo mangiavi lì sugli scogli. Quindi tutte queste cose, soprattutto in un mestiere che crea una suggestione mangiando, sono il vero valore aggiunto che porto con me. In più, secondo me c’è un grande bagaglio che noi procidani ci portiamo dietro, perché veniamo da questo rapporto costante con il viaggio: noi dobbiamo viaggiare per forza, perché non abbiamo nulla, anche banalmente per fare shopping dobbiamo prendere un traghetto, quindi lo spostamento per noi è una parte fondamentale. E la cosa bellissima di questo ultimo periodo è che a Procida stanno tornando delle persone che sono state in giro, che hanno visto cose e le stanno portando a Procida caratterizzandole come procidane, quindi oggi secondo me è un periodo particolarmente positivo per l’isola, perché si sta riuscendo a mettere insieme queste due cose: il fatto di essere più isola delle altre (perché Procida è più isola di Capri ed è infinitamente più isola di Ischia) e allo stesso tempo prendere da fuori e raccontare in una chiave personale.
C: Tornando al 28 posti, cosa resta del ristorante originario e cosa invece è stato completamente rivoluzionato con il tuo arrivo?
M: Diciamo che quando sono arrivato il 28 posti, almeno per quanto riguarda la cucina, non aveva un’identità ben definita. Poi in realtà il ristorante ha un’identità fortissima per la sua origine: 28 posti nasce da questi due ragazzi – i titolari – che come principale occupazione hanno una ONG che si occupa di lavori nel Sud del mondo, in Kenya, in particolare, in questi anni. Ai tempi della creazione del ristorante, loro gestivano la segheria del carcere di Bollate e da questa esperienza nacque il progetto del 28 posti, perché i detenuti che potevano beneficiare di un particolare articolo del codice carcerario, potevano lavorare fuori dal carcere per poi ritornarvi a dormire. In pratica il ristorante è nato con i detenuti: ho lavorato per i primi due anni con il mio pasticcere/panettiere Riccardo, un ragazzo che era in carcere per 17 anni, quindi da questo punto di vista l’identità era già molto forte. Sulla cucina l’abbiamo dovuta creare e noi ci siamo caratterizzati per questa volontà, per questi gusti miei personali di ricerca sul Mediterraneo, innanzitutto perché mi interessa e soprattutto mi interessa tutta la parte antropologica legata al Mediterraneo, questo Mediterraneo che in realtà non viene mai raccontato, se non per le solite cose: quindi per l’inferno che in realtà veramente è per alcuni versi – il disastro dei migranti abbandonati, ad esempio – ma non viene mai raccontato come un’entità geografica complessa ma unica. Siamo più portati a ragionare in termini di Europa, ma la geografia mediterranea viene molto prima di quella politica e, soprattutto, il Mediterraneo viene sempre raccontato in maniera storica, mettendo insieme una serie di eventi, uno dietro l’altro. Noi invece cerchiamo di raccontarlo in maniera geografica, mettendo sullo stesso livello le diverse cose e cercando le cose in comune e quelle che invece sono totalmente diverse perché diventano peculiarità.

La bellezza del Mediterraneo è che può essere considerato non come dei pezzi di terra intorno a un mare, ma come un mare che ha tanti pezzi di terra intorno, quindi considerare il mare come isola e i confini, invece, sarebbero tutte le terre che si approcciano e non soltanto quelle che sono realmente confinanti – noi per esempio in Campania abbiamo tradizioni di baccalà, aringhe, di pesce affumicato, perché? Perché le navi che tornavano portavano questi prodotti e quindi anche in questo c’è sempre un continuo scambio… In realtà il Mediterraneo è un pozzo infinito di ispirazioni da questo punto di vista.
C: Dietro ai tuoi piatti c’è grande sperimentazione, eclettismo, studio, ricerca. Quali sono i tempi di ideazione e realizzazione di un piatto? Quali sono le tue principali fonti di ispirazione (hai un po’ anticipato questa parte della domanda parlando del Mediterraneo)?
M: In realtà i tempi di creazione di un piatto possono essere lunghissimi o istantanei, per un semplice motivo: noi lavoriamo con una serie di tecniche, tantissime di queste inventate da noi, che spesso richiedono un anno, due anni. Abbiamo preparato delle salse o dei prodotti che hanno avuto delle fermentazioni di 2 anni/2 anni e mezzo. Oppure dei tempi di ricerca: per esempio abbiamo lavorato con la produzione di bevande alcoliche ottenute da prodotti non consueti, tipo il vino di pasta, il marsala di pomodoro, la pasta fermentata, quindi tutti prodotti estremamente contestualizzati nel concetto del Mediterraneo, ma che richiedono una tecnica enorme: lavoriamo tantissimo con le spore, con le muffe, che sono ingredienti inusuali chiaramente nella cucina. Abbiamo questo enorme vocabolario di cose che prepariamo e poi, quando è il momento di creare il piatto, in realtà, dobbiamo soltanto andare ad attingere da questo vocabolario, abbiamo già tutto. Poi chiaramente c’è il momento dell’assaggio, ci sono tante cose che concorrono alla preparazione di un piatto: banalmente le temperature o anche semplicemente un taglio. Tagliare in una maniera piuttosto che in un’altra un prodotto cambia la percezione di quel sapore, quindi quella parte lì è la parte più tecnica per rendere al meglio quello che noi vogliamo da quel piatto.
Dal punto di vista delle preparazioni, può durare anche anni: abbiamo un prodotto in particolare, una colatura di melanzane (il processo della colatura di alici ma fatto con le melanzane) che stiamo facendo maturare da 3 anni e mezzo… Sta lì, l’assaggiamo ogni settimana, andiamo a vedere che cosa succede, eccetera, ma non sappiamo quando la useremo, non sappiamo neanche se mai la utilizzeremo, però questo è il nostro metodo di lavoro.
Dal punto di vista dell’ispirazione, invece, che cosa abbiamo fatto negli anni: noi puntiamo a fare delle cose che siano solo nostre, estremamente caratterizzate, non fare cose viste da altri. Quindi qual è il processo: invece di prendere ispirazione dalla cucina, prendiamo ispirazione dall’antropologia, ricreando suggestioni che arrivano da altri ambiti in modo tale che il prodotto sarà solo nostro, perché non ha un’origine legata alla gastronomia o comunque non soltanto a quello.
Abbiamo fatto un piatto che negli anni ci ha portato fortuna, che era a base di tabacco perché volevamo raccontare la storia delle tabacchine di Tricase, in Puglia, e la rivolta delle tabacchine, queste donne che hanno fatto la rivoluzione in un periodo in cui non era pensabile neanche che le donne potessero votare.
Noi l’abbiamo raccontato lavorando col tabacco, con dei cereali coltivati in Puglia, tutta una serie di lavorazioni: è questo il nostro approccio alla cucina, ai piatti.
Martedì prossimo* cambiamo menù e sarà un menù tutto incentrato sul viaggio, per questa voglia di ritornare a viaggiare dopo questo anno e mezzo difficile e quindi racconteremo i viaggi: i viaggi dei marittimi, i viaggi dei popoli che si mettono in cammino. Questo è un poco il nostro punto di partenza, la cosa bella è che noi non sappiamo mai dove arriviamo, sappiamo come dobbiamo lavorare perché è il nostro metodo che abbiamo messo a punto negli anni. Il punto di arrivo non lo sappiamo mai ed è bello perché è sempre una sorpresa, sorpresa che a volte può essere anche in negativo: abbiamo fatto delle preparazioni che a volte sono venute delle schifezze terrificanti, ma chiaramente non sapevamo a cosa andavamo incontro e quindi si prova… Tanto per dirti, noi non compriamo più cioccolato da 4 anni / 3 anni e mezzo ormai, perché ci produciamo un cacao ottenuto da un grano siciliano, non a base di cacao, ma il processo porta alla produzione di un cacao vero e proprio e quindi la cioccolata io me la faccio da solo, con questo grano antico siciliano che utilizziamo anche per il pane. Partiamo proprio da zero per ogni cosa, non utilizziamo semilavorati di nessun genere, cerchiamo di partire sempre da tele completamente vuote per poi arrivare a quello che sarà il risultato.
C: Quando è nata l’idea per il tuo piatto dedicato alla Chiajozza eri a Milano o a Procida?
M: Ero a Milano, quello è un piatto nostalgico. È una cartolina di casa, dove volevo mettere un po’ di quelle cose che ti dicevo prima, che ci portiamo dietro senza neanche saperlo e soprattutto mi piaceva l’idea di dare il nome della Chiajozza perché mi piaceva il fatto che uno a Milano dicesse “ho mangiato la Chiajozza”, “sono stato alla Chiajozza”, mi piaceva questo gioco. Considera che noi cambiamo 6 menù l’anno e li cambiamo completamente… La Chiajozza però ce l’ho sempre, sta sempre lì, ce l’abbiamo sempre pronta all’uso, ormai pure i clienti ci sono affezionati! È un piatto didascalico, perché racconta proprio una baia ed è molto nostalgico.
C: Quale altra tua creazione può essere subito associata a Procida?
M: In realtà di riferimenti ce ne sono tanti, perché ad esempio nel periodo estivo utilizziamo un pomodoro, un sammarzano con cui ci facciamo un piatto e lì il tentativo era di ricreare il sammarzano delle parule giù alla Chiaiolella – mi ricordo che andavamo a raccogliere quei pomodori nell’orto di Totonno Callarano – e lì è una terra che si trova a 50 centimetri sotto il livello del mare, con l’acqua salata che viene filtrata e irriga i pomodori, quindi noi mettiamo i pomodori a marinare nell’acqua di mare, facciamo tutta una serie di passaggi e il ricordo è quello. I riferimenti sono tanti…. In questo momento ho un piatto col cavolo cappuccio** (foto di copertina di Marco Ambrosino), quindi con un riferimento all’insalata di Pasqua sull’isola (quella col cappuccio, l’aglio fresco, la menta, il limone)… Sono molto ricorrenti i riferimenti a Procida.
C: In varie interviste hai affermato che “la cucina è un gesto sociale e un atto politico” puoi sviluppare un po’ di più questa affermazione?
M: Assolutamente: secondo me noi cuochi, soprattutto in questo periodo storico in cui abbiamo un’esposizione enorme tramite interviste, televisione e quant’altro, abbiamo la possibilità (possibilità e non obbligo), una grande occasione storica: possiamo comunicare dei concetti e noi che abbiamo a che fare con prodotti che devono essere salvaguardati perché sono legati all’agricoltura, alla pesca, all’allevamento e soprattutto alle persone che si occupano di agricoltura, di pesca e di allevamento, non possiamo non tener presente queste cose e soprattutto abbiamo un ruolo particolare perché siamo dei moltiplicatori di messaggi. Ogni sera Marco è uno ma i clienti ne sono 30, che parlano con altre 30 persone, che moltiplicano queste cose, quindi da quel punto di vista noi abbiamo la possibilità di incidere.
Dal punto di vista del gesto sociale, cucinare è un dedicarsi: noi non dobbiamo, secondo me, fare semplicemente un buon piatto – quello è il minimo sindacale, nessuno va in un ristorante per mangiare in un posto dove sa che non è buono, andiamo in un posto perché già deve essere buono – dobbiamo pensare al piatto ma soprattutto dedicarci all’ospite, al cliente, all’avventore che viene ogni giorno e farlo con un’attenzione e un rispetto enormi, perché il rapporto tra chi cucina e chi mangia è talmente intimo, noi andiamo da uno sconosciuto che ci prepara delle cose e noi le ingoiamo. Questo genere di rapporto è paragonabile a una connessione con i nostri cari, con la nostra famiglia, i nostri compagni di vita e questa fiducia che ci viene accordata deve essere corrisposta da una maggiore professionalità, da un’estrema attenzione, da un’estrema cura.
Poi c’è pure una questione meno sentimentale ma al pari valida: chi viene al ristorante esce di casa e ha già deciso che ci pagherà.. Noi possiamo andare in un negozio di abbigliamento e non comprare nulla, ma nessuno di noi sogna di andare al ristorante e non pagare. Anche questa fiducia che ci viene accordata, noi la dobbiamo rispettare ed essere i migliori possibili, anche quando siamo stanchi o abbiamo problemi a casa, anche quando siamo nervosi. Dobbiamo essere sempre al meglio perché ci viene riconosciuto questo ruolo. Quindi secondo me questi fattori vanno sempre considerati per chi fa questo mestiere, ogni giorno.
C: Procida 2022, grande gioia per la proclamazione. Detto questo, nell’ambito della ristorazione, ma anche della cultura gastronomica dell’isola quali sono le potenziali sfide e i potenziali benefici per questa nomina e quali, invece, gli eventuali rischi?
M: Partiamo col dire che all’annuncio di Procida capitale della cultura io ho esultato tipo come per la vittoria dei Mondiali. Ero felicissimo perché è un’occasione bellissima! Dobbiamo farci trovare pronti perché è una vetrina enorme e soprattutto non è soltanto gente che verrà a prendere da Procida, ma è un’occasione per noi per prendere da chi verrà: la ristorazione isolana, per esempio, che negli ultimi anni ha fatto già dei passi incredibili, deve mostrarsi nella sua veste migliore, ma soprattutto deve essere pronta a recepire gli stimoli che arriveranno, non la dobbiamo subire questa cosa. Oggi abbiamo mille possibilità di essere informati, di conoscere le cose, di imparare le cose – oggi se qualcuno ti dice “io questa cosa non la so” è perché non l’ha voluta sapere. Stiamo parlando io e te da da una parte all’altra del mondo, quindi si può fare qualsiasi cosa e abbiamo la possibilità di informarci, oggi bisogna fare questo salto qua, bisogna aggiungere quel pezzo e soprattutto, la cosa che bisogna fare, mai come questa volta, è portare fuori Procida: noi a Procida abbiamo delle risorse enormi, sia agricole, sia legate al mare e non c’è veramente nessuna ragione per andare a comprare cose fuori dall’isola, e questo non per uno spirito autarchico o per chiusura, ma perché invece abbiamo quell’occasione di mostrare che possiamo essere più bravi degli altri con la mazzamma, con le alici, con le patelle perché ce le abbiamo, ce le abbiamo solo noi queste cose. Chiaramente tutto ciò richiede più lavoro, più studio, più fatica ma è un’occasione che non tornerà più, è come un atleta di 40 anni che va a fare le olimpiadi, è l’ultima per lui, lo sa che è l’ultima, quindi se la deve giocare al meglio possibile per lasciare la sua firma.
I rischi ci saranno, ci sono già. Noi lo sappiamo che Procida ha tantissime criticità, me ne viene in mente una su tutte che è il traffico, una roba devastante, però allo stesso tempo, porto proprio l’esempio del traffico paragonandolo alla ristorazione: non possiamo lamentarci del traffico e uscire in macchina. I procidani tutti si lamentano del traffico, ma tutti escono in macchina, tutti quanti. Lo sappiamo benissimo: ognuno di noi si è vergognato di passare a San Leonardo con la macchina con i turisti che si nascondono nei portoni, ma nonostante questo continuiamo a farlo. Allora bisogna mettersi in gioco, ma farlo per bene: non mi posso lamentare della clientela che arriva se io attiro quella clientela lì, non mi posso lamentare dei rifiuti per strada se però io li butto tutti i giorni. Migliorare queste cose, è chiaro, è più faticoso. Io lo vedo nel mio lavoro: facciamo un’attenzione enorme allo spreco, facciamo una serie di cose che di solito nei ristoranti non si fanno per etichetta e tutte queste cose sono faticosissime, però se vuoi lavorare in quel modo, se vuoi comunicare quella determinata cosa, lo fai e la fatica viene automaticamente ricompensata dal risultato. Questa cosa qua la dobbiamo fare tutti quanti insieme a Procida, la dobbiamo fare tutti noi che non ci siamo raccontandola e chi è a Procida la deve fare insieme agli altri.
C: Nell’esperienza come docente quali sono i principali valori che cerchi di trasmettere? Come si rapportano secondo te le nuove generazioni col cibo e la gastronomia?
M: Innanzitutto, l’esperienza di docente per me è una delle cose più belle che ho conquistato in questi anni, perché mi piace tantissimo ed è una cosa che se fatta bene, secondo me, poi riesce veramente a incidere sulla vita non soltanto professionale di queste persone, che sono persone in realtà più adulte: tanti miei studenti di cucina hanno già un lavoro e vogliono cambiare vita. Spiegare a una persona di 40-50 anni “guarda, non è semplice questa roba qua, non è per tutti, non è matematico che tu lo farai” è una cosa che ti responsabilizza. Al di là della parte tecnica (quindi di insegnargli delle cose del mestiere), gli faccio sempre questo discorso che è molto poco poetico, molto poco romantico, però è la realtà delle cose: noi non possiamo pensare sempre di portare tutto sul piano della passione – “la cucina è la mia passione”- la passione va benissimo, ma non basta. Dobbiamo avere verso questo mestiere il rispetto che c’è perché è un lavoro, perché ti pagano per farlo, perché con quella paga ci esci con la fidanzata, ci esci con gli amici, ci paghi l’affitto, ci fai la spesa… Quando riesci a capire che queste cose devono andare insieme, diventi un professionista, perché saprai e capirai che dovrai essere professionale anche quando non ne hai voglia. Quindi la passione da sola non può bastare, perché la passione può finire, ci può essere stanchezza, ci può essere il giorno in cui “oggi non me ne frega niente”, ma poi deve arrivare quella cosa lì, il fatto di essere professionista, che ti permette di esserlo tutti i giorni, di essere coerente, di essere migliore di quello che la mattina pensavi di essere.
Dal punto di vista del rapporto dei giovani con la cucina, c’è molta più attenzione perché oggi fare il cuoco è figo, non è più un mestiere di ripiego – una volta nelle cucine ci stava chi non voleva fare niente e lo vediamo, per esempio, con la pizza, che ha avuto un richiamo enorme negli ultimi anni e quello del pizzaiolo è diventato un mestiere con una grandissima dignità, un tempo l’aiuto pizzaiolo era un ragazzo che non voleva fare niente, non voleva andare a scuola e lo si mandava in bottega a imparare. Il messaggio che però bisogna far passare, a tutti i livelli, quindi non soltanto ai cuochi professionisti, ma anche a chi è a casa, è che bisogna ritornare a cucinare. Ritornare a cucinare è l’unica arma che abbiamo contro lo spreco alimentare, contro le malattie legate al cibo, i disturbi alimentari. Questa è l’unica cosa che possiamo fare: a casa bisogna cucinare per i figli, bisogna cucinare per noi stessi – e quello è ancora peggio perché chi vive da solo molto spesso si rompe le scatole pure di fare la spesa per una persona, quindi compra cose confezionate. L’unico modo per uscirne migliori da questo periodo storico è cucinare! È più faticoso, è più stancante, però per esempio, banalmente, è meno costoso.

Questa cosa qua la dobbiamo capire: se riusciamo a capire che da una verdura io posso utilizzare tutto, avremo un risparmio materiale. Cucinando per un bambino, evitiamo di andare incontro a una serie di disturbi che poi arrivano, queste cose bisogna capirle. Poi è chiaro, ripeto, è più faticoso, perché torni da lavoro e proprio non hai voglia di cucinare a casa, però è un passaggio che dobbiamo fare. E come si fa questo passaggio? Si fa rendendolo piacevole: dobbiamo raccontare che è divertente, che è una cosa che ci può dare piacere e ci dà sollievo in diversi modi. Se lo riusciamo a raccontare e noi professionisti riusciamo a dare delle dritte su come poterlo fare in maniera piacevole e senza fare spreco, riusciremo poi veramente a ottenere dei risultati reali, ma bisogna farlo nelle scuole e in tutti i punti di socialità.
C: Sì, cucinare è una cosa per cui anch’io “milito” sempre… Qua a Lille, per un lungo periodo, facevo la spesa da un contadino che una volta a settimana faceva consegne a domicilio di verdure di stagione e lui mi diceva sempre che nel mio condominio io fossi l’unica a ordinare prodotti freschi per poi potermi cucinare…
M: Ma ci credo, perché è più scomodo, ti devi lavare le verdure, te le devi sistemare, 1000 cose che lo sappiamo, sono più scomode, ma è l’unico modo per capire realmente cosa significa mangiare, cucinare, stare meglio. Noi lo sappiamo che non possiamo campare a scatolette, poi uno se si vuole ammazzare s’ammazza. Il problema è anche tutto quello che genera una scatoletta. L’olio di palma in sé non farà neanche malissimo, ma quello che noi combiniamo per coltivare le palme da olio è una devastazione, quello che combiniamo nei mari per mangiare lo stesso pesce, per mangiare tutti quanti il tonno e la spigola, è un disastro. La questione del pesce che non ce n’è abbastanza per tutti è una bugia: non c’è per tutti lo stesso pesce, ma se solo nel Mediterraneo ci sono oltre 300 specie di pesci commestibili, mangiamo pesci diversi! Non tutti dobbiamo avere la tartare di tonno che troviamo ovunque e le solite cose.
C: L’epressione procidana a cui sei maggiormente affezionato?
M: Alla Chiaiolella ci sta una lunga serie di liberi pensatori e mi viene in mente “Povero puorco” un’espressione che veniva sempre utilizzata, poi con tutti i personaggi della Chiaiolella c’è sempre stato un continuo di massime che tra l’altro vanno pure un po’ salvaguardate, perché poi le dinamiche della Chiaiolella l’hanno sempre resa un piccolo paese a sé, con tutti i suoi personaggi e le sue peculiarità.
C: C’è un augurio che vorresti fare alle persone procidane impegnate nella ristorazione, sia a Procida che fuori (quindi anche a te stesso) in vista della nuova stagione di riapertura e, più sul lungo termine per Procida 2022?
M: L’augurio in realtà è anche quello che io faccio a me stesso ogni giorno, ogni mattina: quello di migliorarsi, non perché non siano migliori, ma perché c’è sempre spazio per fare meglio le cose. Mi auguro che tutti quanti colgano l’opportunità per avere una propensione pure a fare la stessa cosa che magari fanno da 30 anni, però a farla con un approccio sempre nuovo, in modo da farla con entusiasmo, senza stanchezza. Quindi non bisogna essere necessariamente innovativi in ogni cosa nel piatto, ma bisogna essere innovativi con se stessi per farlo con stupore, con la meraviglia che ti permette poi di esserne felice.
C: Per finire, una canzone che associ alla cucina, che poi la metto alla fine dell’intervista
M: Ce ne sarebbero una marea, poi in realtà ho un legame particolare – prima te l’ho nominato – con Pino Daniele, come lo abbiamo un po’ tutti penso. Noi qui ascoltiamo veramente di tutto e in maniera ossessiva. Se dovessi dirti una canzone in particolare, mi viene in mente Il mare di Pino Daniele, perché ti mette di buon umore nonostante parli di cose che non funzionano.
*Martedì prossimo: l’intervista è stata realizzata il 17 giugno 2021, quindi il cambio di menù al 28 posti è avvenuto il 22 giugno.
**Piatto col cavolo cappuccio creato da Marco Ambrosino**: Insalata di cavolo cappuccio e piselli alla brace, tartufo nero, colatura di insalata di Pasqua, noce moscata e olio di argan.