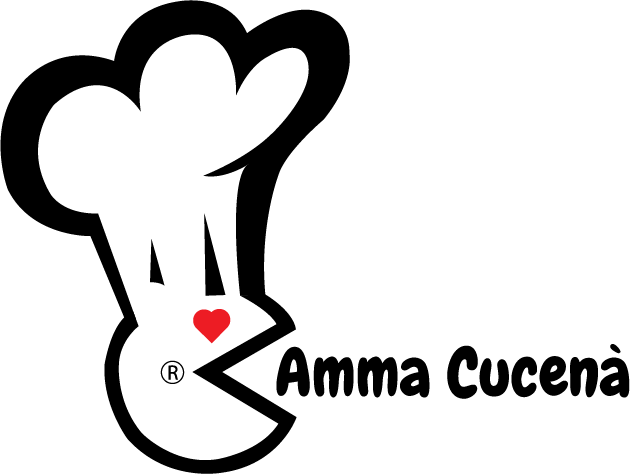M’hanno fatt’a seccia, chéra o chire porta seccia, mi hanno fatto un malocchio oppure quella o quello porta sfiga. A seccia, la seppia, in procidano più o meno moderno e contemporaneo è associata alla sfortuna.
Fortunata è invece la persona che può assaggiare uno spaghetto con pezzetti di seppia – a seccia, per l’appunto – e pomodorini rossi e gialli.
La seccia, in generale, non si pesca d’estate, ma la si può trovare in mare soprattutto nelle stagioni miti, ossia in primavera o autunno inoltrato. Per avere questo connubio perfetto, quindi, si deve comprare una seccia da Paciaccone o alla paranza in tarda primavera, congelarla e tirarla fuori nel periodo di pomodorini rossi e gialli mmiezz’a dd’uorto, oppure si devono congelare pomodorini rossi e gialli e tirarli fuori nel tardo autunno o d’inverno quando una bella seccia sarà reperibile, da pescare e mangiare.
La seppia va comprata sempre fresca, attivare quindi le antenne e osservarla prima di acquistarla: vietato farsi dare “a vatta ‘nto sècco”, detto in altre parole, cerchiamo di non farci fregare. Sta a noi poi congelarla nel migliore dei modi.
In famiglia, ogni qual volta ci è capitata una sfortunella minore, abbiamo sempre attribuito la responsabilità a un fantomatico lancio di seccia rotante da parte di un astratto pluralis maiestatis, associato talvolta a una o più persone ben specifiche più o meno note tra noi.
Pronunciare “M’hanno fatta a seccia” con altisonanza su una propria sventura è di per sé uno sfogo autoironico che alleggerisce le situazioni e personifica la fortuità del caso.
Si è scaramantici dalle nostre parti, e si prendono molto sul serio sia esseri animati o meno che portano sfiga, sia quelli che portano fortuna. Creaturina in carne, pelle e ossa ambasciatrice di buoni auspici è il geco, tarantula in procidano, lacèrtela vermenara in ventotenese. Che dire poi della palummella, – e no, non la cacciare, che porta buone nuove, mandala via solo dal fuoco, proteggila come in Palomma ‘e notte cantata da una nonna, chissà come e dove l’aveva imparata, lei che non sentiva da tempi antichissimi.

Tornando alla lacèrtela vermenara, una zia di mia madre ne ha il terrore e da piccoli, spaventandola per scherzo, mio fratello e io, con la complicità di sua figlia, disegnavamo e ritagliavamo gechi da attaccare alle pareti della casa dove eravamo tutti insieme durante le loro visite. Per lei, quindi, il rettile beige-rosato era tutt’altro che di buon auspicio.
Anni di “è passata a vatta nera”, esclamazione proferita subito dopo l’attraversamento della strada da parte di un gatto nero prima del nostro passaggio a piedi o in auto, in famiglia, non hanno impedito che accogliessimo a casa a Procida un bellissimo felino color pece, pelosissimo d’inverno, tutto spelacchiato in estate. Felix (Pilone per alcuni, Mosci Mosci per papà) era l’amico-nemico del cane Billy arrivato dopo di lui. Può darsi che frequenti cucinazioni di spaghetti cu a seccia abbiano neutralizzato il presunto effetto malefico della presenza di un gatto nero a casa, o che so io, ma fatto sta che gli anni di Felix furono per tutti un periodo piuttosto felice.
Passiamo, invece, alle grane un po’ più serie. Quando avevo dodici-tredici anni, a inizio estate, mi recavo a una festa di paese nell’hinterland vesuviano in compagnia di una cara amica d’infanzia. A lei piacevano molto giostre dispensatrici di emozioni forti, mentre il mio cuore poco temerario si concedeva gli autoscontro come diversivo più pericoloso e si lasciava intenerire dai peluche giganti in palio nei giochi a premi. Mentre camminavamo tra bancarelle e rami metallici da cui partivano tagata, navicelle spaziali, diavolerie che ti facevano stare all’improvviso a testa in giù, non era raro che qualche ragazzo un po’ più grande si avvicinasse a noi chiedendo “State cercanno a ciorta?” “Vulite a ciorta?”. All’inizio, io non capivo la domanda, visto che associavo la parola ciorta a quella aspettata da ognuno in Napul’è di Pino Daniele…
Col tempo, però, l’ombra della ciorta in tal senso si è fatta ai miei occhi più nera di quella del Vesuvio di una miniserie di fine anni Ottanta. La fortuna, intesa soprattutto come buona sorte, in quelle frasi dei giovani della festa patronale vesuviana voleva dire “uomo come compagno o marito”. Se si fanno ricerche su internet sul termine ciorta si legge:
“Si tratta infatti di un termine che ha conservato un’ambiguità semantica che in italiano si risolve con la differenziazione fra fortuna nel senso di “sorte felice”, e sfortuna, il suo tragico opposto. Ma la “ciorta” è anche qualcosa di più: un popolo che crede fortemente nella scaramanzia non poteva non scegliere questa parola anche per descrivere l’incontrollabile che c’è nella vita di ogni uomo, tracciando così il profilo di quel disegno divino (o semplicemente, superiore) a cui chiunque è assegnato. Ciò che in italiano chiameremmo semplicemente “destino”
continua su:
La definizione di “ciorta” in quel senso vesuviano, non l’ho trovata da nessuna parte. Di recente, però, mi è capitato di ascoltare la verbalizzazione di una speranza, rivolta a una ragazza che aveva da poco iniziato a lavorare, affinché la giovane potesse anche trovare una buona ciorta, intesa come compagno o marito, come se non fosse di per sé una gran fortuna avere un lavoro e iniziare a essere indipendente. La cosa mi ha a dir poco stizzita e anche scoraggiata… Il cammino verso una visione tutt’altro che sfigata di una donna che decide di non condividere la propria vita con un uomo è lungo, lunghissimo.
All’epoca, vuoi per la timidezza, vuoi per la sorpresa e incomprensione della domanda, non ebbi nulla da rispondere ai giovani all’ombra del Vesuvio. Oggi mi verrebbe da dire che ci ho messo un po’ di tempo a capire che alla ciorta ho sempre preferito e continuo a preferire la seccia, arrestuta o da tagliuzzare per il sugo e condirci un piatto di spaghetti.

Per alleviare la paura dei gechi in chi la prova, invece, ricorderei la storia della Bella ‘Mbriana. La leggenda narra che un tempo, una principessa a seguito di una delusione d’amore, aveva perso la ragione e vagava per i vicoli della città come un fantasma. Con lo scopo di proteggerla, il re suo padre iniziò a ricompensare con doni anonimi chiunque accogliesse la figlia tra le mura di casa. Fu così che nacque la leggenda sulla fortuna della casa legata alla giovane. Secondo quanto si narra, di solito, quando la Bella ‘Mbriana si fa viva, le tende vicino alle finestre iniziano a muoversi e un’ombra fissa sulla parete indica la sua inequivocabile presenza. Impossibile toccarla, perché a ogni impercettibile movimento o sguardo, lo spirito si trasforma in una leggiadra farfalla (a palummella) o in geco. Di qui l’associazione di questi due animali alle belle notizie e alla buona fortuna.
Il nome ‘Mbriana pare derivi dal latino Meridiana, ossia ora più luminosa del giorno, passaggio del Sole a mezzogiorno. Questa definizione può fare associare la Mbriana alla Controra procidana, come spirito diurno che si intravede da mezzogiorno fino al primo pomeriggio.
Bisogna fare attenzione a non attirare le sue ire quando si fa un trasloco – cosa che potrebbe turbarla – e si consiglia di parlare del trasferimento in una nuova dimora al di fuori delle mura domestiche. Anche se la casa è in disordine o poco pulita la Bella Mbriana potrebbe infuriarsi, quindi si tratta di uno spirito buono ma facilmente irascibile se l’armonia domestica non viene in qualche modo rispettata. Si dice che un tempo si aveva addirittura l’abitudine di conservarle un posto a tavola
Ancora oggi, in alcune zone di Napoli, la Bella ‘Mbriana viene salutata dalle signore anziane all’ingresso di casa, con lo scopo di ingraziarsi la sua benevolenza. C’è da notare, però, che lo spirito pare avere sempre più difficoltà a convivere con le famiglie moderne perché impaurito e infastidito dalla frenesia dei nostri tempi.

Provo immensa tenerezza ogni volta che mi imbatto in un geco, mi ricordo della sua pancia osservata dal calviniano signor Palomar e mi viene da dedicargli Siamo Ospiti, per condividere con lui una condizione che ci accomuna su questa terra, alla fine tutt’altro che nostra. Quindi, trattiamoci e vogliamoci bene e quando non riusciamo, congediamoci augurandoci tutte le buone sorti possibili, senza vuttà secce che poi saremmo comunque in grado di parare, tagliuzzare e cucinare .
Invece, come colonna sonora del post, non potevo non pensare alla nota canzone di Pino Daniele. Immaginando che dietro le sembianze del rettile si nasconda la Bella Mbriana le direi
Bonasera bella ‘Mbriana mia
ccà nisciuno te votta fora
bonasera bella ‘Mbriana mia
rieste appiso a ‘nu filo d’oro
bonasera aspettanno ‘o tiempo asciutto
bonasera a chi torna ‘a casa c’o core rutto.
Ingredienti Per 4 persone
- 500 g di seppie
- Una conserva di pelati da 500 g (oppure, se è estate, 250 g di pomodorini rossi e gialli, oppure, se inverno e sono congelati, tirarli fuori per farli scongelare)
- Uno spicchio d’aglio
- 4 cucchiai di olio EVO
- 2 dita di vino bianco
- Sale q.b
- Pepe q.b
- 500 g di spaghetti n°5 o spaghettoni (prendono bene il sugo)
- Un ciuffetto di prezzemolo
Procedimento
Mettere l’olio e l’aglio in una padella profonda. Non appena l’aglio si imbiondisce, aggiungere il pomodoro. Cuocere il pomodoro per pochi minuti e aggiungere le seppie tagliate grossolanamente versando poi anche le due dita di vino bianco per coprirle. Fare evaporare il vino e aggiustare di sale. Fate cuocere per 15-16 minuti a fuoco medio, facendo attenzione a non fare indurire le seppie (succede se si lasciano cuocere per troppo tempo). A metà cottura aggiungere il peperoncino. Mentre si finisce di preparare il sugo, mettete sul fuoco l’acqua per la pasta. Nel frattempo, cuocere la pasta, scolarla al dente e saltarla per qualche secondo nel sugo di seppie. Servite dopo aver aggiunto una generosa manciata di prezzemolo.
Le fonti consultate per ricostrure la leggenda della Mbriana sono: Eventinapoli, Comune di Napoli e Wikipedia.