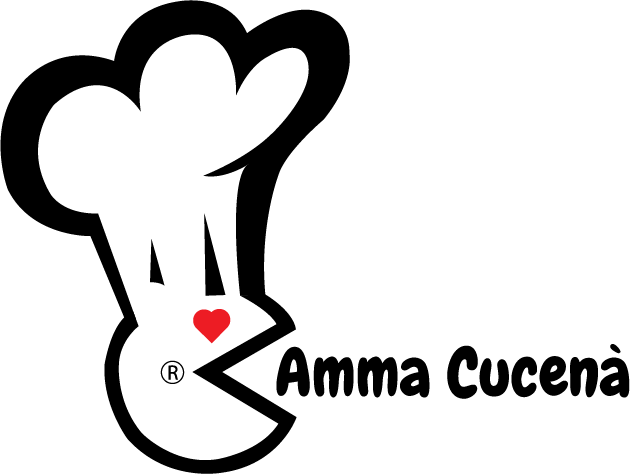La “tristezza non ha fine, la felicità sì”, cantavano i brasiliani riferendosi al Carnevale e al mercoledì che lo seguiva. Il Carnevale, questo chiaroscuro felicità-tristezza, per me lo ha sempre avuto. E no, il Carnevale di Dunkerque, a poco tempo di treno da Lille, non l’ho mai voluto vedere e ora chissà se e quando lo rifanno. Il carnevale non mi attira, neanche quello di Rio raccontato spesso da mio padre. In Brasile vorrò andarci di febbraio, quando si potrà, ma per vedere sante e divinità che escono dal mare e altre misticherie di posti piccoli. E poi per assaggiare acarajé e pão de queijo e cose che si potranno mangiare solo là.
Papà, quando si avvicinava il martedì grasso, raccontava di un funerale, di un fantoccio su un carro funebre pieno di insaccati e di cibarie*. Tutto questo ambaradan, pare, veniva portato in corteo dalla Terra Murata fino a non so dove, forse for o Puzz, forse al porto di Marina Grande. I miei ricordi sono troppo vaghi.
Si narra e si legge che i festeggiamenti del Carnevale durassero in realtà dal giovedì fino al martedì, giorni tutti grassi. Meno di una settimana, non sia mai, u maronn, ci si dovesse confondere tra settimana grassa e settimana santa, comm a mettimm a nomm?
Gioverì muzzidd, chi nun ten sord s ‘mpegn nu figghie, era una frase pronunciata da mio padre la vigilia del giovedì grasso o il giovedì grasso stesso. Papà a volte declamava frasi, proverbi, soprannomi in procidano stretto così, in modo estemporaneo, quando stava seduto sul divano a guardare la tv o a tavola, mentre tagliava le fette di pane prima di mangiare. Se la frase sguinzagliata all’improvviso suscitava la nostra curiosità, lui distoglieva lo sguardo dalla televendita o dalle fette di palatone di turno e ci spiegava il significato del proverbio, identificava famiglia e discendenza del soprannome, evocava l’aneddoto che lo coinvolgeva.
A volte capitava che con un esperto, lesto e discreto colpo di telecomando, dalla tv all’improvviso papà facesse uscire un cantante neomelodico attempato. Lev a stu vatton preistorico! gli dicevo io. E’ truvet u cascion! commentava mia madre. Come rideva lui di quelle nostre incazzature teatrali! Come ridevamo noi di quelle scene diventate ormai una tradizione. La sua risata era contagiosa. Chir è proprio nu carnval, diceva papà riferendosi a qualcuno poco sveglio o dalla presenza ingombrante in generale o in un episodio ben preciso.
Giovedì grasso, chi non ha soldi s’impegna un figlio diceva papà ed era un’esortazione ai festeggiamenti a ogni costo, con costumi, maschere, mascarate, lasagna, ‘nzogna, chiacchiere e sanguinaccio. Dietro “a ogni costo” per me, oltre i soldi, ci sta pure che devi festeggiare pure se non tieni genio. Come non ci piacciono le costrizioni!
I giovedì muzzilli io non li ricordo, ma i martedì grassi procidani sì. Il ricordo più antico e sfocato è un furgone giallo, forse verde, col cascione dietro che agli inizi degli anni ‘80 ci portava a tutt quant, mamme cu’ criaturi in sfilata. Ci stavano pure gli zii. Chi purtav u furgon, chi era vestito da infermiera con la barba. Mio fratello racconta di parrucche, accessori, camici e abiti così improbabili che sgorgavano non appena s’araprev u spicchion a casa di mia nonna materna. Roba da poterci fare carnevale per l’anno in corso e quelli a venire. Non ricordo io da cosa fossi vestita quella volta del furgone. Rivedo coriandoli, il costume di Arlecchino ancora me lo ricordo: diventò il mio preferito addosso a qualche altro bambino. Lo volevo pure io! Quel furgone era lo stesso che ci aveva portati in sfilata per le strade di Procida a festeggiare la vittoria dell’Italia ai Mondiali dell’’82.
E poi ricordi di vestiti scambiati tra me e mio fratello di anno in anno, quello di Pulcinella soprattutto.

Quello di Arlecchino, che un giorno arrivò finalmente anche da me, cucito da una zia. Quello più moderno di Denver, alle medie, creato a regola d’arte da una vicina a Via Curato. Degli anni del liceo ricordo una maschera fantomatica del “fatt accanosc”** arricchita da cerchietti luminosi di Halloween portati in regalo da Diana la canadese, fotografa di mestiere, diventata negli anni amica di famiglia. Come si divertiva a fotografarci!. Io faccio molti mostri, ci aveva detto presentandosi la prima volta e spiegando il suo mestiere in un italiano di sopravvivenza di cui noi in famiglia ci innamorammo immediatamente. Di quella lingua tutta sua accogliemmo subito nel nostro lessico famigliare stramberie e modi di dire che trovavamo saporiti.

Storcevo il naso da bambina e adolescente ogni volta a sentire “a carnevale ogni scherzo vale”, che quelli buttavano le fialette puzzolenti addosso alla gente, i palloncini pieni d’acqua e farina sulla macchina di mamma e a volte pure le uova marce. Per fortuna, pare, le nuove generazioni hanno fatto cadere in disuso queste tradizioni così barbare.
Ogni ricordo di vestiti da provare, di maschere che non fanno respirare da indossare per guardarsi subito allo specchio, riaffiora con l’odore delle chiacchiere preparate da mia madre. Le ha sempre fatte intorno a Carnevale, da gioverì muzzillo, da quando eravamo piccoli. Pure a scuola le portavamo. A casa dei miei non si è mai fatto il migliaccio, le chiecchiere sì. Sempre. Non si faceva neanche il sanguinaccio. Quello lo facevano mia nonna paterna e zia Sceriffo, un sapore introvabile dell’infanzia, il ricordo profumato delle nostre testoline all’indietro per far scorrere l’ultima goccia di quel cioccolato speciale dalla tazzina del servizio buono. Mio fratello ricorda gli avvisi di mia cugina “n’tu mangià, chir e sangue r’ puorc!”***. Ma noi niente. Armati di cucchiaino, biscotto oro saiva, lo finivamo imperterriti e imperturbabili fino all’ultima goccia. Per noi era una felicità che poi è finita con quel tempo, come finiva il carnevale della canzone brasiliana.
Bando alle chiacchiere malinconiche, passiamo alla storica ricetta di mamma.
Ingredienti per 6 persone
- 500 g di farina
- 100 g di zucchero semolato
- 50 g di burro o strutto
- 3 uova
- Un pizzico di sale
- 1 liquore aromatico (noi usiamo il limoncello)
- Abbondante olio di semi di girasole o strutto per friggere
Procedimento
Versare la farina a fontana sul piano di lavoro, rompendo le uova al centro. Aggiungere lo zucchero semolato, il burro (o lo strutto) a pezzetti, un pizzico di sale e un bicchierino di limoncello o del liquore scelto. Impastare per bene tutti gli ingredienti insieme, bisognerà ottenere una pasta consistente. Lasciar riposare l’impasto per un’oretta.

Passata un’ora, stendere la pasta con un matterello, fino a ottenere una sfoglia piuttosto sottile. Ritagliare la sfoglia con una rotellina dentellata: si dovranno ottenere delle strisce della larghezza di 4 cm circa. Da ogni striscia si dovranno formare dei pezzi della lunghezza di circa 5 cm. Da questi pezzi, formare delle strisce da informare. Per dare forma alle chiacchiere seguire i propri gusti: ci possono essere pezzi intrecciati, lisci, annodati. Insomma, sbizzarrirsi a piacimento.

Passiamo ora alla fase della frittura: prendere una padella dal fondo alto e mettervi a scaldare abbondante olio di semi di girasole. Friggere le chiacchiere poco alla volta. Quando saranno diventate ben dorate, sgocciolare le chiacchiere mettendole ad asciugare ulteriormente su carta assorbente. Lasciar raffreddare le chiacchiere e spolverarle con zucchero a velo.
*Il funerale di Carnevale pare fosse un’usanza della Napoli popolare. Per ulteriori approfondimenti, consiglio di consultare Storienapoli.it e Grandenapoli.it .
“fatt accanosc”**: fatti riconoscere
“n’tu mangià, chir e sangue r’ puorc!”***: non te lo mangiare, quello è sangue di maiale!